Il mio lavoro di analisi è concluso.
Per cercare di rispondere alle domande del piccolo elenco che avevo stilato, dovevo mettere a confronto la traduzione di Vittoria Alliata, la traduzione di Ottavio Fatica e la versione originale de “La Compagnia dell’Anello”. Poiché era impossibile fare questa operazione con tutto il libro, a meno che io non fossi disposta a impiegarci anni, mi sono limitata a selezionare alcuni capitoli – pochi ma significativi, secondo me. Ho riempito quaderni e quadernini di appunti vari; la prima e la seconda parte di questo articolo, che per l’appunto provano a offrire delle risposte, sono il risultato di un’opera di sintesi, selezione e rielaborazione di quegli appunti.

Terminata la suddetta fase, oggi sono qui per occuparmi di quella che mi azzardo a definire la pietra dello scandalo: le scelte di Fatica per la traduzione dei nomi di luoghi e personaggi. Dato che Tolkien in persona aveva messo per iscritto una serie di direttive e suggerimenti, Fatica – come Alliata prima di lui – doveva tenerne conto. La “Nomenclature of The Lord of the Rings” si può reperire abbastanza facilmente, quindi a chi non traduce per professione basta un po’ di studio e buona volontà per capire quali indicazioni avesse dato il Professore, in merito alla traduzione del suo capolavoro… ma, prima di addentrarci in questo argomento, lasciate che mi concentri su un’altra questione degna di nota. Vi anticipo che è prevista una quarta parte con le conclusioni, però nel frattempo mettetevi comode/i e leggete questa terza parte 🙂
- Il problema dell’oggettività
Come ho già avuto occasione di dire più volte, l’oggettività totale è impossibile da raggiungere in casi come questo. Un’esperienza di lettura è sempre soggettiva – e non potrebbe essere altrimenti. Il problema, però, è che il giudizio sulla versione di Fatica è spesso influenzato da altri fattori: il legame affettivo con la vecchia traduzione e il “conflitto” tra la STI e l’AIST.
Parlando della vecchia traduzione, sarei sciocca se negassi di averne uno: è grazie all’operato di Vittoria Alliata che ho potuto leggere per la prima volta “Il Signore degli Anelli” in italiano. Sono abituata ai nomi di luoghi e personaggi scelti da lei e da Quirino Principe, mi suonano bene, eccetera. Tuttavia, forse perché ho iniziato a familiarizzare con molti nomi inglesi da ben prima di acquistare la versione originale del libro, frequentando alcuni siti Internet non italiani, il legame affettivo è relativo. In soldoni, né “Samplicio” né “Farfaraccio” mi hanno inorridita; sulle prime sono rimasta un po’ spiazzata, mi pare ovvio, poi però la sensazione è passata. Qualcosa che mi ha fatta inorridire, a onor del vero c’è… ma ci arriverò con calma. Per il momento, sappiate che la mia reazione non ha nulla a che vedere con l’essere affezionata a un nome.
Riguardo al contrasto fra le associazioni, invece, sono estranea alla cosa, quindi non prendo le parti di nessuno. Per me “Il Signore degli Anelli” è innanzitutto una grande passione personale, da condividere con le persone a cui tengo e di cui scrivere sul mio blog; poi, certo, sono contenta che esistano realtà associative che hanno l’obiettivo di studiare le opere del Professore in maniera approfondita, perché è una cosa molto bella e utile… ma finisce lì. Qualsiasi mio giudizio sulla STI o sull’AIST dipende perciò dal modo in cui io, semplice lettrice e appassionata di Tolkien, valuto l’atteggiamento dei rispettivi membri, non dal fatto che io sia schierata dall’una o dall’altra parte.
Un discorso molto simile vale per la questione politica. Lo ribadisco a scanso di equivoci, a me non interessa minimamente ricondurre “Il Signore degli Anelli” a un’ideologia, sia essa di destra o di sinistra. Non conosco i dettagli di ciò che è accaduto in passato, negli anni Settanta, perché sono troppo giovane per saperlo – e non è facile ricostruire la storia di Tolkien in Italia, soprattutto perché le fonti non sono sempre omogenee. Tuttavia, per quella che è la mia esperienza nel fandom, non mi sembra che associare Tolkien e la politica sia diffuso tra semplici appassionati/e: l’unica cosa che ho visto in queste persone è un sincero amore per la Terra di Mezzo. A volte portato un po’ all’estremo, sì, ma di sicuro mai usato per giustificare o incoraggiare una politicizzazione dell’opera tolkieniana. Oserei dire perciò che le letture ideologiche dell’Autore riguardano intellettuali e associazioni… non il fandom. Molte persone che “conosco” – virtualmente parlando – si sono interessate a Tolkien grazie alla trilogia di Peter Jackson… la quale, converrete con me, non associa “Il Signore degli Anelli” ad alcuno schieramento politico. Nessuna di queste persone ha interesse a portare avanti diatribe basate sulla domanda: “È un’opera di destra o di sinistra?”
Detto questo, torniamo al problema dell’oggettività: se le esperienze di lettura sono soggettive, un lavoro di analisi si basa sui dati oggettivi. Per quanto la mia analisi della nuova traduzione possa avere delle imprecisioni, delle mancanze e dei limiti (non mi illudo certo di aver fatto un lavoro completo, perfetto e intoccabile!), tenta di basarsi sui dati, non sulle sensazioni avute durante la lettura. Le sensazioni sono solo la molla che mi ha spinta a dedicarmi a questo lavoro: essendo state perlopiù sgradevoli o spiazzanti, hanno fatto sì che mi domandassi perché ciò era accaduto e, in un secondo momento, mi hanno portata a voler confrontare la traduzione di Fatica con la versione originale, che ho prontamente deciso di acquistare.
Tutto questo discorso sull’oggettività mi serve per ricollegarmi ad alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Fatica, in merito alla sua traduzione. Lo scorso dicembre, infatti, durante una conferenza all’Università di Parma, il traduttore è intervenuto personalmente per spiegare alcune sue scelte, specie riguardanti la nomenclatura. Sulla sua pagina Facebook, l’AIST ha condiviso l’articolo di un blog chiamato “Cercatori di Atlantide”, che al momento sembra essere l’unico resoconto abbastanza approfondito dell’evento (se conoscete altre fonti, potete correggermi nei vostri commenti). Ora, io non so quali sono i rapporti tra l’associazione e chi gestisce “Cercatori di Atlantide”, sempre che ce ne siano… ma non ho potuto fare a meno di notare una tendenza a difendere Fatica più di quanto fosse necessario. Forse nell’articolo sull’incontro a Parma non si nota molto, ma se vi fate un giretto sul blog troverete molto facilmente discorsi che tirano in ballo i “giudizi pre-lettura”, gli “indignati della domenica”, i “nerd conservatori” e gli “hooligan dell’effetto nostalgia”. Sia chiaro, tutte queste cose non sono campate in aria, perché ci sono fan che hanno assunto atteggiamenti aggressivi ed estremisti, attaccando Fatica più volte sui social; lo so, anche se per mia fortuna non ci ho mai avuto a che fare direttamente. Il problema non è riconoscere che esistano tali elementi, ma comportarsi come se Fatica fosse stato una vittima della situazione. Invece, ecco che sul blog spuntano fuori queste osservazioni:
[…] ci ritroviamo in un tempo in cui bisogna parlare, in qualche modo, anche dell’atteggiamento di un traduttore, oltre che del suo lavoro. Il che è assolutamente assurdo e ridicolo, visto che la qualità di una traduzione si presume slegata dalla simpatia del traduttore. Ciononostante uno dei commenti principali relativi a Fatica e al suo lavoro consiste proprio in una serie di giudizi sulla sua supposta arroganza.
[…] Fatica pare essere una persona ben disposta al dialogo e al confronto.
Peccato che ci dobbiamo ricordare che il confronto non consiste in una serie di insulti. O in una serie di giudizi sulla supposta arroganza di Fatica. Giudizi che, da soli, mostrano abbastanza bene l’arroganza di chi si permette di, passatemi l’espressione, sparare sentenze su un tizio che non si conosce.
Parlare dell’atteggiamento di Fatica sarebbe “assurdo e ridicolo”? E perché mai? La qualità di una traduzione non è legata alla simpatia del traduttore, su questo sono d’accordo; ma non vedo perché non si possa esprimere un giudizio sul modo in cui il traduttore in questione si è posto pubblicamente. Piaccia o no, l’atteggiamento di Fatica al Salone del Libro di Torino e l’intervista rilasciata a Loredana Lipperini sono stati il suo biglietto da visita: mi sembra normalissimo che se ne sia parlato. Giudicare fa parte dell’essere umano e, per quanto spesso si traduca in “sparare sentenze”, non si può neppure pretendere che ciascuno smetta di fare commenti o valutazioni sugli atteggiamenti altrui… anche perché giudicare l’atteggiamento non equivale a giudicare la persona. Io non conosco Ottavio Fatica, non so quali siano i suoi princìpi o come si comporti nella vita di tutti i giorni, né m’interessa saperlo; so come si è posto pubblicamente in merito alla faccenda della traduzione, quindi parlo di quello. E sì, per me il suo modo di porsi è stato arrogante. Sto giudicando il suo atteggiamento in un’occasione specifica, non la sua persona. Se poi tanto basta perché sia tacciata io stessa di arroganza, pazienza. Me ne farò una ragione.
A me dispiace che Fatica sia stato bersaglio di attacchi, spesso ingiustificati. È sbagliato che alcuni/e fan l’abbiano insultato come persona e sminuito come professionista. Detto ciò, e chiarito come la penso riguardo ai giudizi sull’atteggiamento… non mi sembra che il traduttore sia stato sempre irreprensibile. Non giustifico assolutamente l’odio in Rete, però – e concedetemi di essere un po’ brutale, perché ogni tanto ne sento il bisogno anch’io – il teatrino sulla nuova traduzione l’hanno cominciato Fatica e l’AIST. È stato Fatica, supportato dall’AIST, a far credere ai lettori e alle lettrici di Tolkien che la vecchia traduzione era approssimativa, piena zeppa di imprecisioni e di errori. È stato Fatica, supportato dall’AIST, a far credere ai lettori e alle lettrici di Tolkien che la nuova traduzione avrebbe rimediato alle lacune della vecchia e avrebbe reso finalmente giustizia all’opera originale. Io non posso dimenticare queste cose. Rispondere a suon di insulti non è giusto, mentre ricorrere alle querele e agli avvocati come ha fatto Alliata non era la soluzione e ha peggiorato la situazione; ma non mi sembra che prima fosse esattamente tutto impeccabile e in ordine. Non dico che Fatica dovesse incensare Alliata, o fosse obbligato ad astenersi dal criticare; però ci voleva un po’ di rispetto in più per una traduzione che, piaccia o meno, ha assunto un valore storico, e per l’operato di una collega che ha lavorato con molte meno risorse a disposizione in confronto a lui (Tolkien era ancora vivo quando Alliata ha tradotto, ma questo è stato il suo unico vantaggio, perché non c’era Internet, né esistevano associazioni di studiosi/e che avessero meditato a lungo l’opera tolkieniana… Non era stato pubblicato neppure “Il Silmarillion”!). Casomai c’era da discutere di più sugli interventi che, nel corso del tempo, hanno apportato modifiche – alcune positive e altre negative, immagino – alla primissima versione della traduttrice siciliana.
A Parma, Fatica ha detto che non era sua intenzione attaccare Alliata. Io posso benissimo credergli, perché a volte non ci rendiamo conto di quanto le nostre parole possano ferire, anche quando le pronunciamo senza cattive intenzioni. Fatica ha detto che “cinquecento errori a pagina per millecinquecento pagine” era solo un’iperbole; e pure a questo posso credere, nonostante mi venga spontaneo chiedermi se “non c’è paragrafo mondo di lacune e sbagli” fosse a sua volta un’iperbole.
Eppure Fatica ha detto anche di non essere stato polemico. A questo, mi spiace per lui, non posso credere. Non avendo letto con i miei occhi, nella sua intervista, che “Il Signore degli Anelli” è stato preso sul serio dopo essere stato tradotto la prima volta, quando l’ha preso in mano il curatore – e l’ho letto. Non avendo sentito con le mie orecchie le parole di un certo traduttore che, al Salone del Libro di Torino, si è messo a cavillare sul numero di righi di un paragrafo e ha fatto passare scelte di traduzione più libere – opinabili, certo, ma questo è un altro discorso – per mere aggiunte al testo. E l’ho sentito. Proprio perché Alliata ha una tendenza a fare delle aggiunte e talvolta a parafrasare un po’, le critiche di Fatica passano fin troppo facilmente come giuste in tutto e per tutto; ci vuole un occhio attento al testo originale per capire quali siano le aggiunte vere e proprie e quali no. E l’AIST, in tutto questo, che ha fatto? Non una sola osservazione critica sulla condotta del traduttore, sebbene al Salone del Libro ci fosse il presidente dell’associazione. No, limitiamoci ad ascoltare Fatica che sta lì a sciorinare esempi dei raddoppi di Alliata. Tra l’altro, ora mi viene in mente una cosa: Fatica, oltre che traduttore, è anche poeta; non gli è proprio venuto in mente che Alliata aveva fatto ricorso a delle figure retoriche? Non dico che fosse obbligato a saperlo, ma stiamo pur sempre parlando di una scelta stilistica che si rifà a Dante e Petrarca, due grandi esponenti della poesia italiana… Un po’ strano che gli sia sfuggito.
Vabbè, torniamo a noi. Non c’è stato alcun tentativo, da parte dell’AIST, di riequilibrare il discorso, per impedire che venisse fuori una divisione troppo netta fra vecchia e nuova traduzione – l’una da considerarsi inadeguata e colma di errori, l’altra fedele, accurata, rispettosa dell’Autore e realizzata da un professionista. Da un’associazione che ha l’obiettivo di studiare le opere di Tolkien e diffonderne la conoscenza, che vuole essere vicina sia agli ambienti accademici che ai lettori e alle lettrici, mi aspetterei un atteggiamento diverso, volto casomai ad abbracciare la complessità, non a ridurre il dibattito in maniera tale che la conclusione a cui si arriva è: abbiamo letto una brutta traduzione per cinquant’anni, ora arrivano l’AIST e Fatica e finalmente ci danno una versione italiana come si deve!
Quindi no, Fatica non è propriamente la vittima della situazione, tanto meno lo è l’AIST. Cerchiamo di non farli passare, al di là dell’atteggiamento scorretto di alcuni/e fan nei loro confronti, come quelli che si sono comportati nel migliore del modi.
Si poteva agire diversamente – si doveva agire diversamente, a mio parere. Perché promettere cose che non si ha la certezza di poter mantenere? Il rapporto del pubblico con la ritraduzione di un’opera amata è sempre delicato, non bisognerebbe mai darlo per scontato o banalizzarlo… Dopo mezzo secolo in cui “Il Signore degli Anelli” ha avuto sempre la stessa traduzione – per quanto rimaneggiata qua e là – e che questa stessa traduzione è stata presa come riferimento per la trilogia cinematografica, era ovvio che un cambiamento avrebbe toccato corde sensibilissime. Con questo voglio dire che non bisognava ritradurre? Assolutamente no, io non sono mai stata contraria all’idea. Intendo che l’operazione doveva essere gestita con più tatto e con meno spocchia. Un professionista come Fatica non aveva certo bisogno di aggrapparsi ai pretesti e squalificare il lavoro altrui, per evidenziare i meriti del proprio.
- E finalmente… la nomenclatura!
Non commenterò la nuova traduzione di tutti i nomi, ma soltanto le scelte che ritengo più problematiche. Per esempio, non discuterò la scelta di tradurre “Farthing” con “Quartiero”, che rispecchia di più il significato del termine originale in confronto a “Decumano” di Alliata, e mi è andata subito a genio. Il mio primo punto di riferimento, ovviamente, sarà il testo di Tolkien; la traduzione di Alliata e le modifiche di Principe verranno menzionate laddove lo ritengo necessario. A volte scivolerò inevitabilmente nel campo dei gusti personali. Se avete delle obiezioni, oppure volete aggiungere qualcosa, contribuite con i vostri commenti.
“Grossa Gente” come traduzione di “Big Folk”. Il termine “big” può essere tradotto in molti modi e “grosso/a” è una delle traduzioni più immediate. Tuttavia, mentre in inglese l’aggettivo prima del sostantivo è la regola, in italiano c’è più libertà e l’aggettivo si può mettere prima o dopo, a seconda dei casi. Ci sono anche delle situazioni in cui il fatto di metterlo prima o dopo conferisce una sfumatura diversa alla frase. Un esempio efficace, sebbene un po’ drastico, è costituito dalle due espressioni “una donna buona” e “una buona donna”, i cui significati sono completamente differenti: nel primo caso “buona” ha un’accezione positiva, ma la seconda espressione è uno dei tanti modi esistenti per riferirsi a una prostituta!
Parlando del termine “gente”, ad ogni modo, la cosa più naturale per la maggior parte degli aggettivi è essere collocata dopo: per esempio, diremmo “gente sciocca” o “gente onesta”, non “sciocca gente” oppure “onesta gente”. Magari Fatica ha optato per “Grossa Gente” perché in italiano “gente grossa” può voler dire “gente rozza e grossolana”; ma come risultato ha ottenuto una forzatura. Alliata sarà stata meno letterale, scegliendo “Gente Alta”, ma almeno l’espressione suonava molto più naturale. Inoltre, aveva il vantaggio di cogliere immediatamente la differenza tra Uomini e Hobbit che salta di più all’occhio: quella legata alla statura.

“Veglio” come traduzione di “Gaffer”. Credo serva una piccola premessa: “Gaffiere” di Alliata non è una traduzione, ma un mero adattamento fonetico del vocabolo originale. In effetti, “gaffer” – che Tolkien usa nell’accezione colloquiale di “old man”, “uomo anziano”, ma che significa anche “vecchio campagnolo”, a sua volta appropriato per Hamfast Gamgee – presenta delle problematicità per la resa in italiano: una possibile traduzione è “compare”, inteso come “appellativo familiare con cui ci si rivolge a un uomo che si conosce”. Il problema è che “compare” può essere anche sinonimo di “padrino”, di “testimone di nozze”, di “complice in un imbroglio” o più semplicemente di “amico”. Fatica sceglie di tradurre con “veglio”, che come significato è appropriato, ma è un termine di registro un po’ troppo elevato per gli Hobbit. Forse, a questo punto, aveva più senso tradurre con “vecchio”, che magari è un po’ anonimo, ma almeno è una parola di uso comune – e un Sam che dice “il mio vecchio” sarebbe stato calzante. Insomma, la scelta di Fatica è buona, ma non mi ha entusiasmata più di tanto. Tuttavia, questo è un caso in cui la traduzione è particolarmente difficile e bisogna scendere a qualche compromesso in più.
“Vico Scarcasacco” come traduzione di “Bagshot Row”. Per la traduzione di “Bagshot Row”, Tolkien raccomanda di includere il termine che, nella lingua di destinazione, corrisponde a “bag” – nel nostro caso, “borsa” o “sacco”. Fatica segue quest’indicazione, ma non capisco perché abbia tradotto “row” con “vico”, termine antiquato o regionale, che peraltro contribuisce alle difficoltà di articolazione del nome della via: insomma, “Vico Scarcasacco” sembra un po’ uno scioglilingua, mentre “Bagshot Row” no. Sorvolando su questa piccolezza, che non pregiudica la qualità della traduzione, mi domando: perché rendere “Bag End” con “Casa Baggins”? “Bag End”, dice Tolkien nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, è associato all’espressione “cul-de-sac”; e Tom Shippey approfondisce la spiegazione ne “La via per la Terra di Mezzo”:
[…] Bag End […] è anche la traduzione letterale della frase che spesso si può vedere scritta alla fine di certe stradine inglesi: cul-de-sac [vicolo cieco]. I cul-de-sac sono al tempo stesso simpatici e irritanti: non appartengono a nessuna lingua, dato che in francese sono chiamati impasse e in inglese dead-end; il termine trae origine dallo snobismo, da quella vaga sensazione, conservatasi fin dai tempi della conquista normanna, che i termini inglesi siano “bassi” mentre quelli francesi, o meglio francesizzati, sarebbero più prestigiosi. Cul-de-sac è perciò un tipico esempio del sentimento di classe inglese e Bag End è una risposta provocatoria e altrettanto inglese.*
Già nella vecchia traduzione – per scelta di Quirino Principe, immagino, come vedremo meglio più avanti – c’era “Casa Baggins”; ma “Bag End”, “Bagshot Row” e “Baggins” sono tutti collegati, proprio in virtù dell’elemento comune “bag”. Se la versione di Fatica si prefiggeva lo scopo di essere migliore della precedente, come mai qui il traduttore fa la stessa cosa che era già stata fatta prima, traducendo “bag” in “Bagshot Row” ma non in “Bag End”?
“Montagna Fiammea” come traduzione di “Fire-mountain”. Non so perché, ma c’è gente convinta che “Montagna Fiammea” sia la traduzione di “Mount Doom”. Non è così: il nome “Mount Doom” compare per la prima volta nel capitolo dedicato al Consiglio di Elrond, e Fatica lo traduce con “Monte Fato”; “Fire-mountain” compare molto prima, quando Gandalf racconta a Frodo la verità sull’Anello, ed è lì che Fatica traduce con “Montagna Fiammea”.
Vediamo di fare quindi il punto della situazione. Il luogo in cui Sauron ha forgiato l’Anello ha due nomi in Grigio-elfico: “Orodruin”, cioè “Montagna della fiamma rossa”, e “Amon Amarth”, cioè “Colle del Destino” – o “del Fato”, se preferite. In inglese, “Orodruin” viene reso da Tolkien in tre modi: “Fire-mountain”, “Fiery Mountain” e “Mountain of Fire”; “Amon Amarth” viene reso con “Mount Doom”. “Mount Doom” è sempre “Monte Fato”, sia nella versione di Alliata che in quella di Fatica. Per il resto, nella vecchia traduzione si usa quasi sempre “Montagna di Fuoco”, indipendentemente da quali siano le forme inglesi di “Orodruin”; se non sbaglio, solo nel capitolo terzo del Libro Secondo compare l’espressione “Montagna Infocata” (in originale c’è “Fiery Mountain”). Non so se si tratti di una scelta precisa o di una svista, anche se ovviamente il significato è sempre quello. L’unica obiezione è che “infocato”, senza u, è probabilmente un po’ meno comune di “infuocato”, che invece credo sia utilizzato più di frequente. Ad ogni modo, nessuno dei termini scelti da Tolkien nel rendere in inglese “Orodruin” è di registro aulico.

Fatica – e la sua è chiaramente una cosa voluta, dato che ricorre più di una volta nel testo – decide di tradurre “Fire-mountain” e “Fiery Mountain” con “Montagna Fiammea”, mentre traduce “Mountain of Fire” con “Montagna di Fuoco”. Era proprio necessario? “Fiammeo/a” è un termine letterario, usato da Giosue Carducci in una delle sue poesie… Perché non scegliere una parola meno altisonante? Le alternative c’erano, non ditemi di no. Poteva chiamarla Montagna Ardente, Montagna Incandescente, Montagna Fiammeggiante… sempre se proprio non voleva mantenere “Montagna di Fuoco” in tutti i casi, che non sarebbe stata una cattiva scelta. In inglese i sostantivi si aggettivano facilmente: lo vediamo appunto con “fire”, che significa “fuoco”, ma se preposto all’altro sostantivo, “mountain”, diventa aggettivo. In italiano questo non può succedere: o si usa il complemento di specificazione, dicendo quindi “montagna di fuoco” e ottenendo lo stesso risultato che si otterrebbe traducendo letteralmente “mountain of fire”, oppure si usa l’aggettivo “infuocato”. Fatica ha optato per il sinonimo “fiammeo”, che ovviamente non è sbagliato, ma secondo me suona un po’ pretenzioso, visto che non è un termine comune.
“Vallea” come traduzione di “Dale”. Il toponimo “Dale” compare già ne “Lo Hobbit”: è la città da cui provengono gli antenati di Bard l’Arciere, distrutta dal drago Smaug prima di installarsi nella Montagna Solitaria. “Dale”, il cui significato è “valle” o “valletta”, è un termine letterario, quindi – anche se nell’edizione Bompiani de “Lo Hobbit” era stato tradotto con “Conca” – la traduzione di Fatica va benissimo. Stavolta il traduttore non alza il registro dell’originale, semplicemente lo rispetta. Il problema, però, è che pure “vale” viene tradotto con “vallea” – per esempio in “Morgul Vale”, reso da Fatica come “Vallea Morgul”. Trovo che “vallea” sia molto ricercato come termine, tant’è vero che non c’è neanche sul mio dizionario Treccani cartaceo; dato che attira l’attenzione, forse sarebbe stato meglio legarlo a un toponimo specifico come “Dale”, in modo che esso rimanesse impresso a chi legge… anche perché lo stesso Fatica, nel prologo, traduce “vales of Anduin” con “valli di Anduin”, quindi lì non usa “vallea”.
Ad ogni modo, qui si sconfina molto nel gusto personale, perciò tutto quello che ho detto sulla traduzione di “Dale” può benissimo essere ignorato.
“Valforra” come traduzione di “Rivendell”. Stavolta c’è davvero molto da parlare. Non possono mancare i riferimenti alle dichiarazioni dello stesso Fatica all’Università di Parma, che sul blog “Cercatori di Atlantide” sono state sintetizzate così:
Parlando invece di Rivendell, che […] Fatica ha tradotto come Valforra, laddove Alliata e Principe hanno preferito Granburrone, si vedono gli ulteriori livelli linguistici di Tolkien. Se si va a vedere nel dizionario, sotto dell c’è una sfilza lunghissima di termini con cui si può tradurre; non solo burrone, ma si arriva fino a orrido. Fatica, qui, ha tradotto con forra, similmente a come Rivendell è stato tradotto in portoghese. Valforra sembra, in realtà, un nome italiano, ma la cosa è voluta; ma anche in inglese, dice Tolkien, esiste un posto chiamato Rivendell.
Sorvolando sul fatto che nella mia copia de “Il Signore degli Anelli” è presente “Gran Burrone”, scritto staccato (immagino dipenda dalle edizioni), ho diverse obiezioni. Per prima cosa, tutti questi significati di “dell” non li ho trovati da nessuna parte – e ho consultato un dizionario cartaceo e tre dizionari online, più l’“Oxford Learner’s Dictionary”, che non traduce ma spiega il significato dei vocaboli. Casomai è tra i sinonimi di “forra” che si trovano sia “burrone” che “orrido”… ma non “orrido” nel senso “che fa orrore”, bensì come sostantivo che vuol dire “luogo dirupato”. Quindi il significato è sempre quello di gola o spazio roccioso tra pareti verticali, conforme all’etimologia del termine “forra” (dal longobardo “furha”, cioè “spazio tra i solchi”). Immagino che chi era presente durante il convegno di Fatica abbia fatto un po’ di confusione.
Ad ogni modo, anche se “dell” avesse molti significati, ciò che Tolkien voleva trasmettere con “Rivendell” è stato esplicitato da lui stesso nella “Nomenclature of the Lord of the Rings”. Fondamentalmente, “Rivendell” è una traduzione della parola in Grigio-elfico “Imladris”, che significa “glen of the cleft”, “deep dale of the cleft”, quindi letteralmente “profonda valle della spaccatura”. “Imlad” corrisponde a “glen”/“deep dale”, quindi a “dell”, “profonda valle”; “ris” corrisponde a “cleft”, quindi a “riven”, cioè “spaccatura, fenditura”.
Fatica ha tradotto con “Valforra”, dunque “val(le)” corrisponde a “dell” e “forra” a “riven”. “Gran Burrone” è una traduzione più imprecisa, ma d’altra parte il burrone è per definizione scavato profondamente nel terreno. Oltre a ciò, vorrei ricordare che nella narrazione si trovano più volte riferimenti alla “valle di Gran Burrone”, per esempio quando Aragorn parla con Éowyn prima di mettersi in viaggio verso i Sentieri dei Morti, oppure quando Frodo si appresta a lasciare la Contea, all’inizio del terzo capitolo del Libro Primo.
Un’altra cosa che non mi torna è che Tolkien abbia detto che in inglese esiste un posto chiamato Rivendell. Nella “Nomenclature of The Lord of the Rings” c’è scritto:
The notes I offer are intended to assist a translator in distinguishing ‘inventions’, made of elements current in modern English, such as Rivendell, Snow-mane, from actual names in use in England, independently of this story […].
Qui Tolkien non dice che Rivendell è un luogo reale, ma che il suo nome è un’invenzione, costituita da elementi di uso corrente nell’inglese moderno. In precedenza, il Professore scrive di aver cercato di trovare nomi che potessero tradurre i termini elfici e, allo stesso tempo, suonare eufonici e familiarmente inglesi alle orecchie degli inglesi, anche se non esistenti in Inghilterra; dopodiché cita “Rivendell” come esempio di traduzione riuscita dall’elfico. Facendo una rapida ricerca su Internet, peraltro, non ho trovato nessun riferimento a un luogo reale di nome Rivendell. Immagino che Fatica non ricordasse bene questi passi della guida alla traduzione… oppure chi ha ascoltato e/o riassunto il contenuto della conferenza ha capito male. Passiamo oltre, in fondo si tratta di una piccolezza.
Devo dire che “Valforra” non mi dispiace come termine. Eppure, alle mie orecchie, ha lo stesso difetto di “Gran Burrone”: la presenza della doppia r! Sono abituata a “Gran Burrone” perché ho cominciato con i film, arrivando al libro solo in un secondo momento; ma, quando ho cominciato a leggere “Il Signore degli Anelli”, ho potuto prendere visione di alcuni toponimi originali, citati nella nota del curatore. “Rivendell” mi è sempre sembrato molto diverso da “Gran Burrone”: con quella doppia l, mi ricordava il suono dell’acqua che scorre, complice anche la somiglianza tra “riven” e “river”, “fiume”. Il significato di “Rivendell”, ovviamente, non c’entra nulla con i corsi d’acqua, ma è pur vero che è presente un fiume nella valle, il Bruinen. Inoltre, la Casa di Elrond è un luogo di riflessione, tranquillità e bellezza, quindi il suono dolce di quella doppia l mi sembra molto più appropriato per un posto del genere, rispetto a quello più aspro della doppia r! Senza contare che in italiano la r è ancor più dura che in inglese (se volete divertirvi a confrontare le due r, andate su Wikipedia alla voce “vibrante alveolare”, che permette di ascoltare il suono della r italiana, e alla voce “approssimante alveolare”, che permette di ascoltare il suono della r inglese). Per questo motivo, credo che la soluzione migliore sia quella proposta dalla traduttrice Francesca Montemagno, citata da Costanza Bonelli durante un convegno all’Università di Macerata lo scorso dicembre: “Fendivalle”. Mantiene il significato del termine originale e conserva la doppia l… Meglio di così!
“Circonvolvolo” come traduzione di “Withywindle”. Devo ringraziare Finrod, un lettore del mio blog, che ha sollevato il problema per primo. Nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, Tolkien spiega che “Withywindle” è modellato su “withywind”, un nome del convolvolo (che, per chi non lo sapesse, è un genere di pianta). Tuttavia, precedentemente chiarisce:
It was a winding river bordered by willows (withies).
“Withy”, infatti, significa “willow”, cioè “salice”, o “willow twig”, “ramo di salice”. In effetti, Withywindle è il corso d’acqua che Frodo, Sam, Merry e Pipino trovano sulla loro strada quando sono nella Vecchia Foresta e cadono vittime del Vecchio Uomo Salice; in entrambe le traduzioni italiane, viene giustamente descritto come un fiume ostruito da salici caduti e fiancheggiato da antichi salici. La scelta di Alliata di tradurre con “Sinuosalice” era ottima, perché conteneva il riferimento al salice, nonché all’aggettivo “sinuoso” – e Tolkien stesso dice che il fiume è “winding”, “sinuoso”. Fatica, invece, ha eliminato il riferimento al salice, preferendo basarsi sulle apparenze, se così si può dire, e inserendo il termine “convolvolo”. Scelta legittima, ma fuorviante rispetto alle indicazioni dell’Autore.
“Farfaraccio” come traduzione di “Butterbur”. Fatica ha tradotto letteralmente: “butterbur” è il nome di una pianta con un gambo spesso e le foglie larghe, che in italiano si chiama appunto “farfaraccio”. Il problema è esclusivamente eufonico: per chi non conosce la pianta e il suo nome, la desinenza “-accio” può far pensare a un dispregiativo. Inoltre, Tolkien riteneva che nella traduzione fosse preferibile la presenza di un elemento equivalente a “butter”, “burro”, anche a costo di scegliere il nome di un’altra pianta. Oppure, in assenza di un equivalente di “butter”, si poteva fare riferimento a una pianta grassa – probabilmente perché l’oste di Bree è un tipo molto in carne. Insomma, questo è uno dei tanti casi in cui il nome è evocativo, perché dice qualcosa del personaggio, essendo il burro una sostanza grassa! Su un vecchio forum italiano dedicato a Tolkien, in tempi non sospetti, un’utente aveva suggerito “Crassulaceo” per rendere “Butterbur” in italiano. In effetti, trovo che sia una buona idea: oltre a rimandare a un termine botanico, “Crassulaceo” richiama “crasso” che, sebbene sia poco comune, è sinonimo di “grasso” e vi somiglia tantissimo. Anche se si perderebbe il riferimento a “butter”, la frase che Gandalf pronuncia riferendosi all’oste – “scioglierò tutto il grasso che c’è in lui”, identica nelle due traduzioni italiane – funzionerebbe lo stesso. Alliata aveva optato per “Cactaceo”, termine che fa pensare subito alle piante grasse. Personalmente trovo che sia più evocativo di “Farfaraccio”, sebbene non rispetti il significato letterale del vocabolo originale; inoltre, anche se il riferimento al grasso è più indiretto, almeno c’è.
“Cavallino Inalberato” come traduzione di “Prancing Pony”. Ecco cosa viene detto su “Cercatori di Atlantide”:
[…] Fatica racconta che i fan si sono, appunto, inalberati, perché avrebbero preferito Cavallino Rampante. Tuttavia, prancing in araldica si usa per dire impennato o rampante per animali come i leoni. I cavalli, invece, anche in italiano non sono detti rampanti, bensì inalberati, secondo il lessico tecnico dell’araldica. Quindi, in realtà, tradurre prancing con impennato o rampante è, de facto, scorretto.
Subito dopo vengono citate direttamente le parole di Fatica:
Io ho detto una cosa giusta, poi se tu sei cresciuto con la traduzione “impennato” […] è un errore. Mi dispiace che tu sia cresciuto con quella cosa lì, ma non so cosa fare.
Per prima cosa, sarebbe stato opportuno precisare se e quando questo riferimento all’araldica è stato esplicitato da Tolkien, dato che non se ne trova traccia nella “Nomenclature of the Lord of the Rings”. In secondo luogo, nessuno dei dizionari che io ho consultato riporta tale riferimento alle voci “prance” e “prancing”, neppure il dizionario etimologico online. Fatica si è comportato come se questa cosa dell’araldica fosse indispensabile, ma non ha spiegato il motivo. Che effetto può fare “prancing pony” a chi è madrelingua inglese? Viene percepito il riferimento? E se non viene percepito, come ci si pone di fronte al vocabolo “prancing”? Il termine suona naturale? Stando ai dizionari, sembrerebbe di sì…
Non ci è stato dato alcun chiarimento in merito. Personalmente trovo che “inalberato”, in italiano, appaia un po’ troppo forzato come termine, specie se accostato a “cavallino”. Non perché sia aulico, ma perché il verbo “inalberare”, in forma riflessiva, si usa anche per le persone, col significato di “adirarsi, sdegnarsi improvvisamente, oscurarsi a un tratto mostrandosi offeso” – quindi può istintivamente suscitare una sensazione un po’ sgradevole, magari facendo pensare a un pony innervosito, oltre che ritto sulle zampe posteriori. Del resto, Fatica stesso ha ironizzato sui fan che si sono inalberati per la sua traduzione di “prancing”. “Cavallino”, invece, essendo un diminutivo di “cavallo”, richiama qualcosa di piccolo e grazioso; è il genere di termine che potrebbe utilizzare un genitore rivolgendosi al proprio bambino, mentre gli mostra un cavallo di piccole dimensioni. Insomma, mi fa pensare a esclamazioni del tipo: guarda com’è carino il cavallino!
Questo è anche il motivo per cui trovo poco azzeccata la scelta di tradurre “pony” con “cavallino” per tutto il testo. Perché non mantenere “pony”, termine attestato anche in italiano? “Cavallino”, in quanto diminutivo, non è particolarmente utilizzato; se ripetuto di frequente, come nel sesto capitolo del Libro Primo nella traduzione di Fatica, rischia di risultare un po’ straniante. Tra l’altro, ricordiamoci che “Il Signore degli Anelli” si concentra in gran parte sul punto di vista degli Hobbit… e perché mai gli Hobbit dovrebbero ricorrere a un diminutivo per riferirsi a qualcosa le cui dimensioni si adattano perfettamente alle loro?

Ma poi, a parte lo stridore che percepisco tra “cavallino” e “inalberato”, mi domando: è davvero corretto bollare come errore una scelta traduttiva – “impennato” – che rispetta il significato del termine originale, pur non mantenendo il riferimento all’araldica? Stiamo pur sempre parlando dell’insegna della locanda di un villaggio, mica di un blasone. Capirei una critica a “puledro”, ma dire che “impennato” è un errore mi sembra un po’ come dire che “Farfaraccio” è scorretto perché non mantiene il riferimento a “butter”.
“Selvalanda” come traduzione di “Wilderland”. Questa traduzione non mi dispiace e il termine scelto da Fatica mi suona molto fiabesco. Vediamo cosa dice Tolkien nella guida alla traduzione:
Wilderland. An invention (not actually found in English), based on wilderness (originally meaning country of wild creatures, not inhabited by Men), but with a side-reference to the verbs wilder ‘wander astray’ and bewilder.
“Landa” può significare anche “terreno in abbandono”, tuttavia nella nuova traduzione si perde il riferimento a “wild creatures”, che invece è mantenuto nella vecchia, “Terre Selvagge”. “Selvaggio” può essere associato sia ai luoghi, sia alle piante, sia agli animali; “Terre Selvagge” fa subito pensare a un posto dove non abitano gli uomini, ma casomai le bestie – essendo il termine connesso all’idea di primitività, di selvatichezza. Inoltre, suggerisce anche che si stia parlando di un luogo difficile da attraversare, se non addirittura pericoloso, nonostante manchi una chiara connessione con i concetti di “andare alla deriva” e “disorientare” menzionati da Tolkien. La traduzione risulta quindi più efficace rispetto a “Selvalanda”, in cui il riferimento al termine “selvaggio” è meno immediato: trovando “selva”, l’immagine evocata dal toponimo può anche essere semplicemente una terra piena di boschi.
“Frodo Baggins” che resta “Frodo Baggins”. Cito da “Cercatori di Atlantide”:
Fatica afferma che Frodo significa che è stato reso saggio dall’esperienza. Infatti, aggiungo io, il nome originale nella lingua hobbit era Maura, in cui maur- significa appunto saggio/esperto. Tolkien, quindi, ha reso maur- con il suo equivalente in germanico antico, frod-. E Fatica sottolinea quanto simile sia questo nome a quello di re Froda in Beowulf, che è uno dei testi di riferimento di Tolkien.
Tuttavia, chi non legge il libro in inglese, ma in una lingua basata sul latino, pensa a frode. Però, a furia di leggere Frodo, Fatica dice che ormai non associo più questo nome a frode. Tuttavia, lasciando il nome così com’è, al lettore italiano non verrà in mente saggio. Per questo Alliata aveva inizialmente tradotto il nome di Frodo in Savio, poi riportato alla forma originale da Principe.
“Alliata aveva inizialmente tradotto il nome di Frodo in Savio”… Fonte? Non possiedo la primissima traduzione de “La Compagnia dell’Anello”, ma questa cosa non ricordo di averla letta da nessuna parte – neanche sugli articoli del sito dell’AIST. Forse qualcosa mi è sfuggito. Comunque stiano le cose, qui non c’è molto da dire. Può far sorridere l’idea che il nome hobbit di Frodo fosse Maura, che in Italia è un nome femminile; ma Tolkien, nell’Appendice F de “Il Signore degli Anelli”, dice che i nomi hobbit maschili terminano con la a, mentre quelli femminili con la e oppure con la o. Riguardo all’associazione di noi italiani/e tra “Frodo” e “frode”, effettivamente può succedere. Una cosa buona è che “frodo” come equivalente di “frode” è ormai antiquato; e non penso che sia particolarmente usato nella sua seconda accezione, se non in espressioni come “merce di frodo” o “cacciatori di frodo”. Ad ogni buon conto, non è fattibile evitare possibili associazioni del pubblico italiano tra la parola “frodo” e il nome del Portatore dell’Anello. L’unica soluzione sarebbe appunto tradurlo, come si è detto che abbia fatto Alliata.
Affronterò il dilemma “nomi originali o nomi tradotti” alla fine di questa terza parte. Per il momento, mi permetto una personalissima considerazione, basata solo sui miei gusti: la sonorità di “Frodo” mi piace molto, perché all’asprezza della lettera r si accompagna la delicatezza della lettera d. Abbiamo quindi una prima sillaba dal suono più duro (“fro”) e una seconda sillaba dal suono più dolce (“do”). Nel secondo capitolo del Libro Primo, Gandalf dice che gli Hobbit sono al tempo stesso “soft” e “tough”; per me Frodo incarna meglio di tutti la coesistenza tra queste due caratteristiche, quindi sono contenta di percepirla riflessa, in qualche modo, anche nel suono del suo nome.
Ora parliamo un attimo di “Baggins”, che è rimasto invariato. Fatica lascia intendere che sia stata la Bompiani a non voler tradurre questo cognome, ma precisa che in tutte le altre lingue è tradotto.
Insomma, siamo noi ad aver sbagliato per tutto questo tempo.
Casomai è stato Quirino Principe a “sbagliare”, visto che Alliata aveva tradotto “Baggins” con “Sacconi”, coerentemente con le indicazioni lasciate da Tolkien nella “Nomenclature of the Lord of the Rings”, che sottolineava come la traduzione di “Baggins” dovesse contenere un elemento col significato di “sack, bag”. D’altra parte, però, bisogna considerare che la versione curata da Principe è quella che ha plasmato l’immaginario collettivo italiano.
“Samwise Gamgee” che diventa “Samplicio Gamgee”. Questa è una delle scelte che hanno sollevato maggiori proteste. Su “Cercatori di Atlantide” la cosa è stata commentata così:
[…] è un caso eclatante quello di uno youtuber che noi non nomineremo, il quale ha ben pensato di vomitare sulla scelta di tradurre Samwise con Samplicio perché, a detta sua, “Samwise vuol dire ‘saggio’, perché contiene la parola ‘wise’”.
Non so chi sia questo youtuber, anche se mi sono fatta un’idea. Ad ogni modo, qui la faccenda è un po’ più complessa di quel che sembra. Vediamo com’è stata spiegata la scelta traduttiva durante l’incontro all’università:
[…] samwise significa poco saggio o, per citare Fatica, “non sei una cima”. Fatica non voleva adattare Samwise in Samvise, come nell’edizione Alliata-Principe, perché non significa nulla. Allora, Fatica ha pensato a sempliciotto o simplicio in italiano. Così Samwise è diventato Samplicio, anche perché poi per tutto il libro viene sempre chiamato Sam e si poteva mantenere la sillaba iniziale.
Tutto giusto… peccato che nell’Appendice F de “Il Signore degli Anelli” – che, vorrei precisare, nella guida alla traduzione Tolkien raccomanda di leggere – venga esplicitato che i nomi hobbit maschili, solitamente, non hanno significato nel linguaggio quotidiano. Per quanto riguarda il caso specifico di “Samwise”, Tolkien dice:
[…] Sam and his father Ham were really called Ban and Ran. These were shortenings of Banazîr and Ranugad, originally nicknames, meaning ‘halfwise, simple’ and ‘stay-at-home’; but being words that had fallen out of colloquial use they remained as traditional names in certain families.
[“The Lord of the Rings”, Appendix F]
I nomi completi di Sam e suo padre erano in origine dei soprannomi; dopo essere scomparsi dal linguaggio colloquiale, avevano finito per diventare semplici nomi tradizionalmente usati in alcune famiglie. Visto che Tolkien stesso ha puntualizzato che i nomi maschili, per il popolo hobbit, di solito non significavano nulla, è molto probabile che il significato di quelli in questione fosse stato dimenticato col tempo. L’Autore aggiunge:
I have therefore tried to preserve these features by using Samwise and Hamfast, modernization of ancient English samwís and hámfœst which corresponded closely in meaning.
[“The Lord of the Rings”, Appendix F]
Quindi “Samwise” è una modernizzazione ortografica del termine originale in inglese antico. La scelta di adattare in “Samvise” ha un minimo di senso, specialmente se teniamo conto che è stata fatta quando l’inglese era meno diffuso in Italia; ricordiamoci che la w nell’alfabeto italiano non esiste! È vero, così facendo si perde il significato del nome completo di Sam, ma d’altra parte questo significato non è molto esplicito. L’origine del nome del nostro giardiniere, infatti, viene spiegata da Tolkien anche in una lettera del 1944 al figlio Christopher, allora ventenne:
[…] Sam non è l’abbreviazione di Samuel ma di Samwise (che è ingl. antico per “mezzo-saggio”, “sciocco”) come il nome di suo padre […] sta per l’i.a. Hamfast o Casalingo.
[“Lettere 1914/1973”, J.R.R. Tolkien, a cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, traduzione di Lorenzo Gammarelli, Bompiani, 2018]
Ricordiamoci che Christopher, per quanto giovane, aveva preso un po’ di lezioni dal padre – che peraltro, in alcune lettere, gli scriveva frasi in inglese antico. Se Tolkien si è preso la briga di dire al figlio cosa vuol dire “Samwise”, deduco che il significato non è così immediato per chi è madrelingua inglese. Al contrario, “Samplicio” evoca subito il concetto di semplicità alle orecchie di chi parla italiano, anche senza bisogno di conoscere il nome “Simplicio” (che deriva dal latino “simplex”, ovvero “semplice”). Penso che, leggendo “Samwise”, la prima cosa che noterebbe chi parla inglese moderno sarebbe proprio l’elemento “wise”. E benché “Samwise” non significhi “saggio”, ma “saggio a metà”, associare Sam con la saggezza non è del tutto insensato, perlomeno se prendiamo in considerazione l’evoluzione del personaggio. Lo stesso Tolkien, in quello che originariamente era l’epilogo de “Il Signore degli Anelli”, gioca sulla presenza del termine “wise” all’interno del nome completo di Sam. Nella lettera che Aragorn manda al giardiniere, infatti, c’è scritto: “Perhael (i sennui Panthael estathar aen)”, ovvero “Samwise (who ought to be called Fullwise)”, che tradotto alla lettera significa “Mezzo-saggio che dovrebbe essere chiamato Completamente-saggio”. È vero che poi questo epilogo è stato scartato, ma ciò non cambia il fatto che Sam, nel corso della storia, sia maturato – e quindi possa meritare di essere chiamato “Fullwise”. Di certo più di un fan crede che Sam rappresenti la saggezza, o comunque sia un personaggio saggio; è giusto spazzare via i fraintendimenti e chiarire che “Samwise” non significa “saggio”, ma un’associazione tra Sam e la saggezza non è completamente fuori luogo.

Come se non bastasse, resta da considerare il problema legato alla pronuncia. In Italia tendiamo a pronunciare il suono æ come se avessimo davanti la lettera e, un po’ perché nel nostro alfabeto fonetico questo suono non esiste e un po’ perché, probabilmente, siamo influenzati/e dalla pronuncia americana, che rispetto a quella britannica tende di più verso la e, meno verso la a (aggiungo qui il link di una pagina dove, se vi va, potete ascoltare la differenza tra i due tipi di pronuncia). Insomma, per noi italiani/e è come se ci fosse scritto “Sem”. Già “Samvise” è problematico, perché non si capisce bene come vada pronunciato: se dovessimo leggerlo all’italiana, allora lo pronunceremmo esattamente com’è scritto… però non assomiglia a un nome italiano, quindi ci viene da pronunciarlo “Semvais” o “Semvis”. Nel doppiaggio della versione cinematografica abbiamo una sorta di ibrido tra inglese e italiano: “Sam-” è pronunciato come un vocabolo inglese, “-vise” come un vocabolo italiano. Non credo sia una cosa che viene molto naturale (personalmente non avrei mai usato questa pronuncia, se non l’avessi sentita nei film), ma se non altro “Samvise” non sembra un nome italiano, come dicevo prima, perciò ha un minimo di senso trattare la a da e, cosa che poi viene spontanea con l’abbreviazione “Sam”. “Samplicio”, invece, ha l’aria di un nome italiano, da pronunciare così com’è scritto, eppure difficilmente penseremmo lo stesso del suo diminutivo. Insomma, la faccenda del nome completo di Sam – ed è proprio il caso di dirlo – è tutto meno che… semplice!
“Meriadoc Brandybuck” che diventa “Meriadoc Brandaino”. La traduzione del cognome di Merry non ha suscitato particolare entusiasmo… ma andiamo con ordine e vediamo cosa è stato detto a Parma:
Merry è un altro nome […] che è meno semplice di come appare.
Infatti, secondo Tolkien bisogna leggere merry senza pensare ad allegro. Infatti, merry è solo una riduzione di Meriadoc e andrebbe, secondo il Professore, ritenuta come priva di significato al momento della traduzione.
Meriadoc, invece, è una parola gallese, che deriva da mawr (grande) e udd (signore), ossia “gran signore”.
“Secondo Tolkien bisogna leggere merry senza pensare ad allegro”… Fonte? Nella “Nomenclature of The Lord of the Rings” non c’è scritto niente del genere, mentre nella già menzionata Appendice F compaiono queste parole:
Meriadoc was chosen to fit the fact that this character’s shortened name, Kali, meant in the Westron ‘jolly, gay’, though it was actually an abbreviation of the now unmeaning Buckland name Kalimac.
[“The Lord of the Rings”, Appendix F]
Perfino nelle bozze di quest’appendice, presenti in “The History of Middle-earth” (“HoME”, come spesso la si chiama per abbreviare), viene esplicitato che “Meriadoc” è stato scelto perché fornisce l’abbreviazione “Merry”; e l’abbreviazione del nome di questo Hobbit in Ovestron (o Westron, se alla versione italiana preferite il termine originale) è una parola che significa “felice, allegro”. La differenza è che, nelle suddette bozze, il nome in Ovestron è diverso rispetto a quello che compare nella versione definitiva dell’Appendice F, pubblicata ne “Il Signore degli Anelli”; ma questo è comprensibile, essendo l’Ovestron una lingua inventata, i cui vocaboli venivano talvolta modificati o perfezionati da Tolkien. La sostanza, ad ogni modo, non cambia: l’abbreviazione del vero nome di Meriadoc, qualunque esso sia, vuol dire “allegro”.
Ma poi, perdonatemi, come sarebbe possibile pretendere di “leggere merry senza pensare ad allegro”? Sarebbe come chiedere a un/a italiano/a di leggere il nome “Felice” e di non pensare all’aggettivo “felice”. Non mi pare possibile. Mica è una cosa che si decide di fare o di non fare, semplicemente viene spontanea, se si è madrelingua… e questo vale per “Felice” in italiano come per “Merry” in inglese.
Riguardo a “Brandaino”, in questo caso Fatica ha seguito le indicazioni di Tolkien, che nella guida alla traduzione specifica l’etimologia di “Brandybuck”: se “brandy” è un riferimento a “Brandywine River”, “buck” deriva dai termini in inglese antico “bucc” e “bucca”, che si riferiscono rispettivamente al maschio della famiglia dei cervidi – quindi anche il daino, il capriolo, eccetera – e al maschio della capra. Il problema è che, non essendo stato tradotto “Baggins”, né adattato foneticamente “Gamgee”, il cognome tradotto di Merry stona un po’. Su questo discorso, ad ogni buon conto, torneremo più in là.
“Peregrin Took”, detto “Pippin”, che diventa “Peregrino Took”, detto “Pippin”. Anche qui c’è molto da dire. Cominciamo, ancora una volta, con i riferimenti all’intervento di Fatica a Parma:
Pippin, nella versione di Fatica, è rimasto Pippin. Il traduttore afferma di non capire bene perché nell’edizione Alliata-Principe lo si sia trasformato in Pipino, a meno che non si stia facendo riferimento, goliardico, a Pipino il Breve.
Non mi sembra difficile capire che “Pipino” è stato probabilmente scelto per ragioni di assonanza: “Peregrino” e “Pipino” contengono entrambi la lettera i e la lettera o. Nella vecchia traduzione, i due nomi condividono perciò la stessa desinenza, “-ino”… come in originale “Peregrin” e “Pippin” condividono la desinenza “-in”. Questione di eufonia, insomma. “Peregrino soprannominato Pipino” suona un po’ più credibile rispetto a “Peregrino soprannominato Pippin”. Ma andiamo avanti:
[…] all’orecchio di un lettore inglese, il nome Pippin richiama subito un tipo di mela, una specie di renetta. […] Pertanto, noi in italiano dovremmo chiamarlo Renetto o Melozzo, ragiona Fatica, ma il pubblico sarebbe impazzito. Eppure Tolkien voleva che il pubblico pensasse alla mela o al pip, il seme.
Inoltre, aggiungo io, il nome completo Peregrin, di radice latina, sarebbe la traduzione del nome hobbit di Pippin, ossia Razanur. Razanur, infatti, contiene la radice raza (straniero) e razan (forestiero), ed era il nome di un viaggiatore famoso.
A me pare che qui si citi Tolkien solo quando e come fa comodo. Stranamente, nessuno si è ricordato di citarlo quando dice che “Hamfast” e “Samwise” erano scomparsi dal linguaggio colloquiale. Comunque sia, anche se “Pippin”, in inglese, richiama subito un tipo di mela, mi sembrano doverose alcune precisazioni: il termine deriva dall’inglese medio “pipin”, abbreviato in “pip”, che significa “seme” – come sottolineato giustamente su “Cercatori di Atlantide” – e deriva a sua volta dal francese antico “pepin”. Ancora oggi, “pépin” significa “seme”… ma, guarda caso, in francese Pipino il Breve si chiama Pépin Le Bref. Non dico che l’etimologia del nome proprio debba coincidere con quella del nome comune, ma intanto una cosa è certa: in francese i due nomi sono uguali. Come se non bastasse, sebbene in inglese lo si chiami Pépin come in francese, Pipino il Breve in tedesco si chiama Pippin. Ne “Il Signore degli Anelli”, scegliendo “Pipino” come traduzione si perde il riferimento alla mela… ma la connessione tra “Pippin” e “Pipino” non è del tutto campata in aria, né incomprensibile.
Riguardo a “Took”, Tolkien suggeriva di adattarlo foneticamente nella lingua di destinazione: ecco perché nella vecchia traduzione troviamo “Tuc”. Fatica ha preferito lasciare il cognome identico all’originale, con il risultato che il nostro giovane Hobbit ha per nome un termine italiano (“Peregrino”), per soprannome un termine inglese (“Pippin”) e per cognome un termine inglese (“Took”). Coerente, vero? E in tutto ciò, Fatica si permette pure di dire questo:
Quando poi si passa ai nomi, bisogna fare una premessa: non c’è un calco preciso per questa roba. Anche perché le lingue nordiche sono molto facilitate rispetto a noi, ma a parte questo non è coerente nemmeno Tolkien. Pare che io stia dicendo un’eresia, ma non è vero. Senza offenderlo, aveva pensato di fare questa cosa, poi ci aveva ripensato, si è ricreduto, ha spiegato le cose in un modo e poi in un altro, il suo tentativo è bellissimo, ma ha le sue falle.
[…]
Non c’è una coerenza, e quindi come fai a renderlo? Non ci riesci nemmeno tu. Noi abbiamo fatto un compromesso, discutibilissimo.
Ora, io apprezzo molto che Fatica abbia riconosciuto la difficoltà di tradurre Tolkien e di aver dovuto fare un compromesso… ma attribuire a Tolkien incoerenza sui nomi mi pare un’assurdità. Sia chiaro, il Professore era un essere umano, per quanto geniale, quindi poteva sbagliare anche lui; su certe cose cambiava idea, scriveva e riscriveva. Tutto questo, però, non mi sembra sufficiente per dire che non fosse coerente riguardo ai nomi, che per lui erano assolutamente fondamentali per la costruzione della storia. Ce lo ricordiamo o no, com’è nato “Lo Hobbit”? Eppure, su “Cercatori di Atlantide” si rincara la dose:
[…] come si è visto, i nomi dei quattro protagonisti non hanno un’etimologia omogenea. Frodo ha radici germaniche, Samwise inglesi, Peregrin latine e Meriadoc gallesi. E tutti, in qualche modo, sono traduzioni di parole hobbit.
[…] Per questo motivo [ovvero il fatto che non c’è una coerenza, come detto dal traduttore], Fatica ha lasciato invariati Frodo, Merry e Pippin, traducendo invece Samplicio e Brandaino.
Anche “Lucia” e “Debora” hanno radici differenti, visto che il primo deriva dal latino e il secondo dall’ebraico, eppure sono entrambi nomi italiani. Seriamente, ma che discorsi tira fuori la gente? Il fatto che i nomi abbiano un’etimologia diversa non è una dimostrazione di incoerenza. Innanzitutto, nonostante i nomi dei nostri quattro Hobbit non siano necessariamente inglesi, gli elementi di inglesità non mancano: “merry”, “pippin” e “took” sono parole inglesi, così come “peregrin”, che pur avendo radici latine si trova senza troppe difficoltà su alcuni dizionari d’inglese; “Brandybuck” contiene “brandy” e “buck”, parole inglesi; “Gamgee” è un cognome realmente esistente in Inghilterra, anche se forse non di origini inglesi; “baggins”, come attestato da Tom Shippey nel terzo capitolo de “La via per la Terra di Mezzo”, è un termine che in buona parte della Gran Bretagna indica il tè, inteso come qualsiasi pasto secondario consumato tra i pasti principali; “Samwise” contiene la parola inglese “wise”, e l’abbreviazione “Sam” è un nome diffuso nelle zone anglofone, sebbene abbia origini ebraiche. Quanto a “Meriadoc”, potrà essere un po’ straniante rispetto al resto, ma la scelta di un nome con etimologia gallese è pienamente consapevole, perché Tolkien voleva che i nomi dei Bucklanders fossero diversi da quelli del resto della Contea e suonassero vagamente celtici, come dimostrano le sue parole contenute nell’Appendice F e nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”. Non a caso, infatti, il nome del capostipite della famiglia a cui appartiene Merry, Gorhendad, è una parola gallese (significa “bisnonno”).
A questo punto, resta “Frodo” da considerare. Come spiegato a Parma dallo stesso Fatica, questo nome ha origini germaniche, e Fróda è un personaggio menzionato nel poema “Beowulf”. In norreno il nome è Fróthi e viene citato sia dal poeta Snorri Sturluson, sia dallo storico Saxo Grammaticus, che parlano della “pace di Fróthi”, un periodo di prosperità e serenità che rappresenta l’età d’oro nella mitologia nordica. Oggi come oggi, è difficile che chi legge faccia tutte queste associazioni, ma non è impossibile che il nome “Fróda” – che, come notiamo, differisce da “Frodo” solo per la lettera finale – suoni come qualcosa di già sentito. Ad esempio, in alcune opere ottocentesche del poeta tedesco Friedrich de la Motte Fouqué, sono presenti vari eroi delle saghe germaniche; in particolare, ne “Il cavaliere di Aslauga” compare un personaggio di nome Froda. Louisa May Alcott menziona più volte “Il cavaliere di Aslauga”, nel volume conclusivo della sua celeberrima saga “Piccole donne”, e fa degli accenni alla trama dell’opera:
Era la meravigliosa storia di Foqué che narra del cavaliere Froda e della bella figlia di Sigurd che, angelo o spirito, appariva al suo innamorato nelle ore del pericolo, come in quelle della gloria e della gioia, diventando la sua guida e il suo custode, ispirandogli coraggio, nobiltà e lealtà, conducendolo a grandi imprese sul campo di battaglia, a sacrificarsi per quelli che amava, e alla vittoria su se stesso, finché dopo la morte egli trovò l’amato spirito ad attenderlo e a premiarlo.
[“I ragazzi di Jo”, traduzione di Emma Mozzani, Fabbri Editori, 2003]
Come se non bastasse, dobbiamo sempre tenere a mente che, per Tolkien, i nomi hobbit maschili non avevano significato nel linguaggio di tutti i giorni. “Frodo” potrà suonare strano o senza senso alle orecchie di un/a inglese, ma non sarebbe un male; si tratterebbe probabilmente di un effetto previsto dall’Autore.
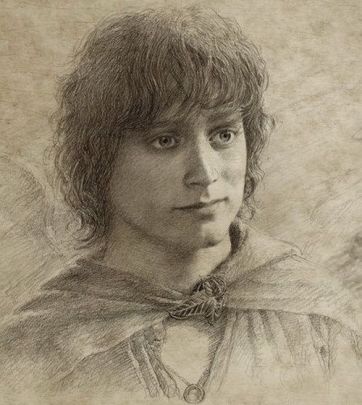
Nelle bozze dell’Appendice F contenute nella “HoME”, troviamo un interessante passaggio, nel quale viene esplicitato il nome hobbit di Frodo e subito dopo c’è il seguente chiarimento:
Questo non era un nome comune nella Contea, ma penso che una volta avesse un significato, anche se esso era stato a lungo dimenticato.
Ma non è finita qui. Se si osservano con attenzione gli alberi genealogici contenuti nell’Appendice C del capolavoro di Tolkien, si noterà la somiglianza tra i vari nomi, a seconda delle famiglie di appartenenza. I Baggins hanno tutti nomi brevi, composti da due sillabe, e quelli maschili terminano tutti con la lettera o. I Took hanno nomi più lunghi; quelli femminili terminano solitamente in a, più di rado in e, mentre quelli maschili in s, d, m, n. Tra i Brandybuck ricorrono sia nomi più lunghi, sia nomi più brevi; quelli maschili terminano solitamente in c, oppure in s. Nei nomi maschili della famiglia Gamgee, ricorrono più di una volta gli elementi “ham”, “son” e “wise”, e alcuni nomi si ripetono: ci sono due “Hamfast” e, se consideriamo anche la famiglia del cugino al quale accenna il padre di Sam nel primissimo capitolo, tre “Halfred” e due “Holman”. Pure l’elemento “man” ricorre più di una volta – e accomuna la famiglia Gamgee con la famiglia Cotton, peraltro anch’essa di estrazione sociale modesta, all’interno della quale troviamo i nomi “Tolman”, “Cotman” e “Bowman”.

Oltre a ciò, non mancano le assonanze e le allitterazioni tra i nomi dei padri e dei figli. Nel caso di “Meriadoc”, la desinenza finale “-doc” risale addirittura a sei generazioni precedenti; compare in tutti i primogeniti di queste generazioni, escluso “Rorimac”, il nonno di Merry (che mantiene comunque la c finale): Gormadoc, Madoc, Marmadoc, Gorbadoc, Saradoc.
Anche i nomi di padri, figli e fratelli della famiglia Took si somigliano molto fra loro. Fa eccezione “Gerontius”, che suppongo dovesse distinguersi dagli altri, perché mi sembra l’unico nome maschile latino in tutto e per tutto. Ad ogni modo, per quanto possa risultare straniante rispetto ad altri nomi, anche “Gerontius” conserva l’allitterazione col nome del padre, “Fortinbras”; inoltre, nella narrazione viene chiamato più spesso “Old Took”, anziché col nome proprio. E ancora una volta possiamo vedere l’importanza del significato dei nomi per Tolkien, dato che “Gerontius” deriva probabilmente dal greco γέρων, “gérōn”, ovvero “uomo vecchio”. Senza contare che la famiglia Took è proprio una di quelle in cui bisogna aspettarsi di trovare nomi altisonanti – e il latino non è forse considerata una lingua dotta?
In some old families, especially those of Fallohide origin such as the Tooks and the Bolgers, it was, however, the custom to give high-sounding first-names.
[“The Lord of the Rings”, Appendix F]
Per quanto riguarda i nomi femminili, Tolkien si attiene alla sua stessa affermazione nell’Appendice F, secondo cui le bambine hobbit avevano solitamente nomi di fiori o di gemme. Spesso, infatti, è così – e vale per tutte le famiglie presenti negli alberi genealogici dell’Appendice C.
Tornando un attimo a Frodo, sebbene il suo nome possa suonare un po’ strano, nei primi capitoli vengono menzionati alcuni membri della sua famiglia, permettendo a chi presta maggiore attenzione di notare le caratteristiche dei nomi maschili dei Baggins: brevità e lettera o finale. Abbiamo Bilbo, Otho, Lotho, Drogo. Di nuovo possiamo notare le allitterazioni e le assonanze tra i nomi dei padri e dei figli: Frodo è figlio di Drogo, Lotho è figlio di Otho. E Bilbo, sappiamo già grazie a “Lo Hobbit”, è figlio di Bungo.
Ovviamente sono scelte volute. Ne abbiamo la conferma nelle bozze dell’Appendice F, dove Tolkien ammette esplicitamente:
Io, in ogni caso, ho fatto la ‘traduzione’ con parecchia cura. L’inclinazione […] dei padri a dare ai propri figli nomi allitterati con i loro o simili nella parte finale, è stata debitamente rappresentata.
Tutto questo dovrebbe lasciar intendere che Tolkien sapeva bene quello che faceva e seguiva dei criteri. Il Professore si fingeva un traduttore, che doveva far sì che i termini tradotti dall’Ovestron suonassero inglesi e/o eufonici per il pubblico inglese. Ma l’Ovestron è un’invenzione di Tolkien stesso, quindi è normale che lui modificasse i termini di questa lingua, secondo le proprie convinzioni e convenzioni estetiche.
La coerenza non dev’essere necessariamente legata alle etimologie dei nomi non espressi in Ovestron: le etimologie possono essere differenti, senza che per questo ci sia incoerenza. Casomai sono le traduzioni de “Il Signore degli Anelli” – quindi le traduzioni della traduzione, se stiamo al gioco dell’Autore – a rischiare di essere incoerenti. Posso immaginare, anche solo vagamente, la grande difficoltà di tradurre un’opera come quella di Tolkien, nonché l’impossibilità di mantenere la stessa coerenza e gli stessi effetti da lui cercati. Per noi italiani/e, “Frodo” è un caso emblematico: ha un significato completamente diverso da quello a cui può risalire chi è madrelingua inglese, o comunque chi parla una lingua germanica. E che dire di “Gerontius”? Immagino che suoni un po’ più familiare alle orecchie di un/a italiano/a che a quelle di un/a inglese – anche se ormai il latino viene abbastanza snobbato qui in Italia! Ma questi sono limiti intrinseci dell’arte della traduzione, perché ogni lingua di destinazione è sempre diversa dalla lingua di partenza e ciascuna ha le sue peculiarità, le sue origini, le sue influenze. Ecco, forse sarebbe stato meglio sottolineare questo, anziché dire che Tolkien non è coerente coi nomi.
“Forestali” come traduzione di “Rangers”. Forse il termine più discusso della nuova traduzione. Al di là delle battute scherzose o pungenti, se n’è parlato molto sul Web. Le analisi di questa scelta traduttiva hanno cercato di andare a fondo della questione, come dimostra un post sulla pagina Facebook “Le radici profonde”. In sostanza, chi difende la decisione di Fatica sostiene che “Forestali” copra quasi tutte le accezioni di “Rangers”, mentre chi avversa la decisione di Fatica sostiene che “Forestale” sia limitato e inadeguato.
Senza entrare direttamente nel merito della discussione, vorrei fare una riflessione partendo dalle dichiarazioni dello stesso Fatica:
[…] la vecchia traduzione aveva raminghi. Ora, a me raminghi sembra un tipo di ordine di frati, non mi convince. Se la prima traduzione avesse avuto scritto forestali e io avessi tradotto con raminghi mi avrebbero mandato a ramengo a me.
Comunque, io ho scelto forestali, perché? Perché questi sono dei signori che vanno su e giù lungo i confini della Contea per tutelarli da una potenziale minaccia, e loro nascostamente vagano proteggendo.
Riguardo a forestale, mi avevano detto “ma sembra una guardia forestale”. Eh, e ranger che sembra? Aveste detto ranger a un ragazzo inglese dell’epoca è a questo che penserebbe. Ranger significa questo in inglese.
Niente di difficile, insomma. Fatica ha scelto “Forestali” perché secondo lui è coerente col significato del termine originale e con il ruolo dei personaggi nella storia. Non viene fatto alcun cenno ad altri aspetti della questione, come ad esempio il fatto che “forestale” derivi da “foresta”. Ma cerchiamo di capire cosa intendesse comunicarci Tolkien con “Rangers”. Christina Scull e Wayne Hammond, nel volume “The Lord of the Rings: A Reader’s Companion”, individuano in “Ranger” il senso di “wanderer”… quindi “vagabondo, girovago”. Stiamo parlando della prima accezione del termine secondo l’“Oxford English Dictionary”, che “forestale” non copre. Il massimo che si può fare è un’associazione con il termine antiquato “foresto”, che vuol dire “selvatico, solitario” (ma è anche un regionalismo col significato di “forestiero”). “Foresto” viene dal latino “foris”, cioè “fuori”, dal quale probabilmente deriva anche “foresta” – che dà origine a “forestale”. Ma “forestale”, di per sé, non c’entra nulla con la gente che vaga, al contrario di “ramingo”, che c’entra eccome.
Qualcuno, a questo punto, potrebbe dirmi: se la parola “ranger” ha tanti significati, come reagisce chi legge la versione originale ed è madrelingua inglese? Ebbene, nel capitolo in cui poi verrà introdotto il personaggio di Aragorn, Tolkien scrive:
[…] in the wild lands beyond Bree there were mysterious wanderers. The Bree-folk called them Rangers, and knew nothing of their origin.
[“The Lord of the Rings”, Book I, Chapter IX, “At the Sign of The Prancing Pony”]
Come possiamo vedere, si parla di “misteriosi vagabondi” (ovviamente il grassetto è mio). Essendo l’accezione di “wanderer” la prima presente sull’“Oxford English Dictionary”, ed essendoci proprio il termine “wanderers” nella frase che precede quella in cui compare “Rangers”, permettetemi di dubitare che un ragazzo inglese dell’epoca avrebbe pensato esclusivamente a una guardia forestale. Forse poche persone sapevano che “ranger” significa anche “wanderer”, ma dubito che non lo sapesse proprio nessuno.
Ne “Il Signore degli Anelli” esistono poi i Rangers dell’Ithilien, uomini scelti da Denethor, che hanno il compito di attraversare in segreto l’Anduin e tendere degli agguati agli Orchi. Parliamo di un corpo militare, che gira per un territorio allo scopo di pattugliarlo – ed è chiaro che l’accezione scelta non è la prima presente sull’“Oxford English Dictionary”, bensì la terza. Anche questa volta, Tolkien ci indirizza sul significato da attribuire alla parola “rangers”; Frodo e Sam hanno appena incontrato gli uomini di Faramir, e due di essi vengono presentati così:
They named themselves Mablung and Damrod, soldiers of Gondor, and they were Rangers of Ithilien; for they were descended from folk who lived in Ithilien at one time, before it was overrun.
[“The Lord of the Rings”, Book IV, Chapter IV, “Of Herbs and Stewed Rabbit”]
La parola “soldiers” (da me evidenziata) richiama inevitabilmente all’ambito militare, quindi non dovrebbe essere così difficile capire dove voglia andare a parare l’Autore con quel “Rangers”.

Tornando ad Aragorn e ai Dúnedain, invece, nonostante la gente di Bree li chiami “rangers” nel senso di “vagabondi”, essi in realtà agiscono in segreto per proteggere il Nord dalla minaccia di eventuali nemici, come ha spiegato Fatica e come lasciano intendere anche Scull e Hammond, i quali definiscono i Rangers del Nord “protectors of Eriador”. Da questo punto di vista, può avere senso la connessione con le guardie forestali; siamo alla seconda accezione del termine “ranger” sull’“Oxford English Dictionary”, che è quella più comune nei moderni dizionari d’inglese… e sappiamo che alla guardia forestale è affidato un compito di tutela. Delle zone boschive, d’accordo, ma sempre di tutela si tratta.
Alla luce di ciò, possiamo dire che Tolkien ha scelto “rangers” perché sapeva di poter fare affidamento sui vari significati della parola. La terza accezione vale per i Rangers dell’Ithilien, la prima per i Rangers del Nord. La seconda accezione non vale per né gli uni né per gli altri (né gli uomini di Faramir né i Dúnedain sono guardie forestali o guardaboschi), ma contiene una suggestione, quella legata al concetto di tutela e protezione, che è applicabile a entrambi. Non dimentichiamo, inoltre, che ai Dúnedain si può comunque attribuire la funzione di pattugliare (sebbene essi non costituiscano un vero e proprio corpo militare), affiancando alla prima accezione di “rangers” una sfumatura di significato proveniente dalla terza.
Il punto è che Tolkien si è potuto permettere di fare questo, perché la lingua inglese lo consente; l’italiano no. Bisogna decidere quali significati sacrificare – a meno che non si scelgano due termini diversi per riferirsi rispettivamente ai Rangers del Nord e ai Rangers dell’Ithilien. “Forestale”, oltre a non coprire affatto il significato di “wanderer”, rimanda troppo facilmente al Corpo Forestale dello Stato (che oggi fa parte dell’Arma dei Carabinieri). Questo rende il termine straniante e fuori contesto agli occhi di un/a italiano/a che legge. Oltre a ciò, bisogna tenere in conto che sono gli abitanti di Bree a chiamare “Rangers” quelli come Aragorn, e gli abitanti di Bree non conoscono la verità su questi misteriosi individui. Avrebbe davvero senso se li chiamassero “Forestali”? Solo perché “forestale” deriva da “foresta”, che probabilmente condivide la stessa radice etimologica dell’obsoleto “foresto”, che significa “selvaggio”/“selvatico”? Un tantino stiracchiata come associazione. È vero che neppure “raminghi” copre tutti i significati di “rangers”, ma rispetto a “forestali” ha due vantaggi: non stona con l’atmosfera generale del libro e corrisponde all’accezione fondamentale attribuita ai Rangers del Nord, quella di “wanderers”.
Ha senso che la gente di Brea chiami “raminghi” i Dúnedain, perché appunto vede che vagabondano – senza sospettare cosa facciano in realtà. Non dico che sia una traduzione perfetta, si tratta semplicemente di un compromesso. È un po’ come tradurre “gaffer” con “veglio”: si rispetta il significato, ma non il registro. “Ranger” è un termine comune, mentre “ramingo” ha una sfumatura poetica, viene usato da Manzoni e Foscolo; “veglio” è forse più poetico ancora, essendo utilizzato da Petrarca e Dante, al contrario di “gaffer”, che pur essendo in disuso appartiene al linguaggio colloquiale. Forse “Veglio” stona di più rispetto a “Raminghi”, per il semplice fatto che il primo è il soprannome di uno Hobbit campagnolo e viene usato soltanto nella Contea, mentre il secondo – come scopriamo nel corso della lettura – si riferisce a ciò che resta nel Nord degli Uomini di Númenor. Ad ogni modo, lo ribadisco, si tratta di compromessi.
“Ramingo” si rivela inadeguato quando ci spostiamo in Ithilien… ma bisogna considerare che “Rangers” compare una sola volta in riferimento ai soldati di Gondor: per la maggior parte della narrazione, è associato ai Dúnedain. Inoltre, non mi sembra che “forestale” sia un gran miglioramento. Ha quell’elemento militaresco che manca completamente a “ramingo”, ma suona troppo moderno per la Terra di Mezzo. Una traduzione deve sempre tenere conto delle peculiarità della lingua di destinazione; come dicevo, in italiano “forestale” fa pensare al Corpo Forestale dello Stato. E se questa associazione può essere accettabile per gli uomini di Faramir, non vale lo stesso per i Dúnedain. In originale, Tolkien aiuta chi legge a orientarsi, inserendo “wanderers” quando vengono introdotti i Rangers del Nord e “soldiers” quando vengono introdotti i Rangers dell’Ithilien; nella vecchia traduzione c’è scritto che “nelle zone selvagge oltre Brea vi erano misteriosi vagabondi […] i Raminghi”**, affermazione che non ha nulla di straniante. Nella traduzione di Fatica, invece, ci troviamo a leggere che “nelle zone selvagge al di là di Bree giravano misteriosi vagabondi […] i Forestali” °°. Cosa c’entra il vagabondare con le guardie forestali? Niente. Ed ecco che il pubblico medio si confonde, si stranisce, o addirittura viene scaraventato fuori dalla storia.
Evidentemente Fatica ha sottovalutato il problema, oppure si è accontentato del fatto che la traduzione più immediata di “ranger” è proprio “guardia forestale” (è la prima traduzione che oggi si trova consultando i dizionari d’inglese). Insomma, il traduttore ha compiuto una scelta legittima, che va rispettata come tutte le altre, ma alla prova dei fatti risulta poco efficace.
“Boscuro” come traduzione di “Mirkwood”. Alliata aveva tradotto “Mirkwood” con “Bosco Atro”. Su Internet c’è stato chi ha criticato la cosa, adducendo come motivazione il fatto che “Bosco Atro” è composto da due parole e “Mirkwood” da una, oppure considerando la scelta di Alliata frutto di una sua passione esagerata per Dante. Vediamo cosa dice Tolkien nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”:
Mirkwood. A name borrowed from ancient Germanic geography and language, chiefly preseved in Old Norse myrkviðr, though the oldest recorded form is Old German mirkividu. Not preserved in English, though Mirkwood is now used to represent Old Norse myrkviðr. Translate by sense, if possible using elements of poetic or antique tone.
Quindi Tolkien dice di usare un tono poetico o antico, se possibile. È quello che ha fatto Alliata scegliendo “atro”. Potevano esserci soluzioni diverse; Caterina Ciuferri, traduttrice de “Lo Hobbit” per Bompiani, ha optato per il meno aulico “tetro”. In “Boscuro” può essere contenuto “scuro” oppure “oscuro”, ma la sostanza non cambia: il termine non risulta poetico.
Bene, sono arrivata alla parola che mi ha veramente inorridita e che boccio senza alcuna possibilità di appello: “Colbree” come traduzione di “Bre-hill”. Sì, per me è inaccettabile. Quando l’ho letta mi è parso di ritrovarmi, invece che nella Terra di Mezzo, a navigare in Internet sui siti dove la gente dice “shippare”, “triggerato” e roba del genere. Chi mi segue sa quanto io poco sopporti questi neologismi che mescolano l’italiano con l’inglese, spesso risultando – almeno alle mie orecchie – alquanto cacofonici. Dico, ma era così difficile tradurre con “Colle Bree” o “Colle di Bree”? In inglese, come in altre lingue germaniche, creare parole composte viene molto più naturale che in italiano. L’abbiamo visto con “Fire-mountain”, ma esempi ancor più rappresentativi possono essere “Mirkwood”, “Rivendell” e “Brandybuck”: ciascuno di questi tre nomi composti riesce a unire due termini, senza dover sacrificare nessuna lettera e senza suonare innaturale… diversamente da un “Brandaino”, nel quale il riferimento alla parola “brandy” diventa meno evidente e possono esserci difficoltà con la pronuncia, perché non si capisce se l’accento debba cadere sulla i oppure sulla seconda a.
Tra l’altro, un conto è unire due parole italiane, come nel caso di “Valforra”; un conto è unire una parola italiana con una parola inglese – e in maniera così evidente, poi! “Bree” non è un termine italiano, si vede lontano un miglio; “Colbree”, preso singolarmente, che idea suggerisce a chi parla italiano ma mastica un minimo di inglese, come tante persone in Italia al giorno d’oggi? “Cole” + “bree”? “Cold” + “bree”? È pur vero che il libro aiuta a capire in quale contesto ci troviamo, ma perché forzare sull’italiano un meccanismo molto più congeniale all’inglese? Alliata qui era stata più rispettosa della natura della lingua italiana, spezzando il toponimo in due, come del resto aveva fatto con “Bosco Atro”.
Il termine “Colbree” non sembra essere stato preso in considerazione durante l’incontro a Parma, ma credo torni comunque utile una citazione dell’articolo pubblicato su “Cercatori di Atlantide”:
[…] per Fatica, l’importante […] consiste nel rimanere coerenti. Quindi, se questi nomi sono stati univerbati (val+forra= Valforra, val+fano= Valfano), allora una simile scelta va fatta anche per tutti gli altri nomi composti. Per questo motivo, quindi, Mirkwood non sarà Bosco Atro o Bosco Scuro, ma Boscuro.
Perciò, anche se la lingua di destinazione non è una lingua tendenzialmente agglutinante com’è invece quella di partenza, bisogna univerbare tutti i nomi composti, altrimenti si è incoerenti. Non fa una grinza. A questo punto, visto che “Mirkwood” è stato tradotto con “Boscuro” e “Bree-hill” con “Colbree”, perché non tradurre “Middle-earth” con “Mezzoterra” o “Terramedia”?
- Alcune note a margine
Sarcasmo a parte, credo sia chiaro che la traduzione di Fatica ha dei problemi. Mi rendo conto che non fosse sempre facile seguire la guida alla traduzione, perché Tolkien l’ha stilata pensando alle lingue germaniche, che ovviamente condividono una stretta parentela con l’inglese. L’italiano ha radici diverse, quindi è comprensibile volersi talvolta distaccare dalle indicazioni del Professore. Il punto è che Fatica sembra non aver seguito un vero criterio, mescolando nomi originali e nomi tradotti in maniera apparentemente inspiegabile. Perché, ad esempio, è stato tradotto “Samwise” ma non “Hamfast”? Il risultato è che la famiglia ha un cognome inglese (“Gamgee”), i suoi membri hanno nomi composti da parole inglesi (oltre ad “Hamfast”, troviamo “Holman” e “Halfast”), eppure stranamente il nome completo di Sam è “Samplicio”. A questo punto, era meglio lasciare inalterato anche “Samwise”.
Una cosa che non mi piace particolarmente, inoltre, è che il traduttore sembra un po’ troppo orientato all’auto-giustificazione. A Parma, verso l’inizio dell’incontro, ha detto queste parole:
I tolkieniani, nel bene o nel male, sono dei settari. Stanno stretti nel loro mondo e sono partiti dall’idea che la nuova traduzione avrebbe fatto sicuramente schifo.
Caro signor Fatica, conosco una tolkieniana che era partita da ben altri presupposti – e non era l’unica. Capisco che molte persone le abbiano fatto una brutta impressione, ma è proprio necessario fare di tutta l’erba un fascio? La verità è che è molto facile dividere in “noi” e “loro”: un po’ perché chi sbraita – in questo caso, chi si è scandalizzato/a per “Samplicio”, “Brandaino” e via discorrendo – tende a sovrastare chi solleva delle obiezioni sensate, un po’ perché fa comodo attribuire il torto agli altri e la ragione a sé stessi. Per Fatica, tutto pare ridursi alla contrapposizione tra lui, il professionista che ha fatto il suo lavoro, e il fandom, composto da gente chiusa di mente, che si arrabbia perché troppo legata al suo “vecchio peluche”:
Io non sono uno specialista di Tolkien. Avevo letto molti saggi e conoscevo bene gli Inkling, però Tolkien l’ho letto solo recentemente. E per certi versi è un bene, perché forse se lo avessi letto anni fa questa conoscenza mi avrebbe un po’ tarpato le ali, perché magari anch’io sarei cresciuto con Samvise e avrei detto che non l’avrei mai cambiato. Insomma, io non voglio strappare il vecchio peluche dalle mani di nessuno.
Insomma, chi non apprezza la sua traduzione è accecato/a dalla nostalgia. Fine della trasmissione.
Peccato che la realtà sia un po’ più complessa di così. Fatica ha svolto il suo lavoro come riteneva giusto ed è ovvio che certe cose le capisca molto meglio del pubblico, essendo traduttore di professione; ma ciò non vuol dire che un/a fan che lo critica sia per definizione incapace di separare l’effetto nostalgia dalle osservazioni basate sui fatti. Che nella nuova traduzione ci sia una mescolanza di nomi originali e nomi tradotti, che dà un’impressione di scarsa coerenza, è un fatto. Che Fatica non abbia seguito alcune delle indicazioni di Tolkien è un fatto. Possono esserci i motivi più sensati del mondo dietro le decisioni del traduttore, però questo non cambia i risultati.
Poi, scusate, ma a me l’idea di voler rompere con il passato sembra abbastanza evidente. Tralasciando casi isolati come “Casa Baggins”, “Campi Iridati” e “Omorzo”, è quasi come se ci fosse stata una corsa ai cambiamenti non necessari. Fatica ha affermato:
[…] non ho tradotto per distanziarmi da Alliata, stavo solo facendo una cosa diversa, ho ritradotto.
Ebbene, non posso fare a meno di chiedermi: “Roggiargento” dove prima c’era “Argentaroggia” è una ritraduzione? E “Baccadoro” dove prima c’era “Baccador”? E “Mezzomo” dove prima c’era “Mezzuomo”? E “Anello Unico” dove prima c’era “Unico Anello”?
Forse sarebbe stato meglio venire un po’ più incontro al pubblico, evitando le modifiche non indispensabili, che hanno tutta l’aria di cambiamenti fini a sé stessi. Evidentemente, trovare un compromesso con i lettori e le lettrici di vecchia data non interessava a nessuno. Come se non bastasse, su “Cercatori di Atlantide” troviamo le seguenti affermazioni:
[…] Fatica fa notare anche che un altro obiettivo della nuova traduzione consisteva nel togliere Tolkien dall’angolo della libreria in cui ci sono i fantasy, i gadget, i manga. In questo modo, si sarebbe potuto riportare il Professore nell’angolo della letteratura, perché Tolkien è un ottimo scrittore del Novecento.
Tolkien non ha bisogno di essere riportato “nell’angolo della letteratura”, perché si trova lì già da tempo. Tolkien non necessita di alcuna liberazione, perché il fantasy non è una gabbia ed essere classificato – o classificabile – in questo genere non è una vergogna, non deve far pensare che non abbiamo a che fare con “un ottimo scrittore del Novecento”. Si può collocare tranquillamente “Il Signore degli Anelli” accanto ad altri classici in libreria, non c’è problema… Perché, però, farlo con certe motivazioni? Il fantasy potrà pure essere associato ai “gadget e ai manga”, ma è letteratura. “Il Signore degli Anelli” non è soltanto fantasy (la studiosa Verlyn Flieger, nel suo saggio “A Post-modern Medievalist”, definisce simpaticamente il libro di Tolkien “una sorta camaleonte”), ma ciò non significa che associarlo a questo genere sia fuori luogo o sbagliato. “Grande del Novecento” e “scrittore fantasy” non si escludono a vicenda; perché dovrebbero? Non è dato saperlo, a quanto pare.
- Nomi originali o nomi tradotti?
Ed eccoci al grande dilemma che rende difficile – più di quanto già lo sia – l’approccio al testo di Tolkien da parte di chiunque si trovi a tradurlo: mantenere i nomi originali oppure no? Forse non tutti lo sanno, ma il Professore era inizialmente sfavorevole all’idea di tradurre i nomi. Nel 1956, in una lettera riguardante la traduzione olandese de “Il Signore degli Anelli”, scrisse:
Di principio sono il più fermamente contrario possibile a ogni “traduzione” della nomenclatura (anche se fatta da una persona competente). Mi chiedo perché un traduttore dovrebbe sentirsi chiamato o autorizzato a fare una cosa simile. Il fatto che sia un mondo “immaginario” non gli dà alcun diritto di rimodellarlo a suo capriccio, nemmeno se potesse in pochi mesi creare una nuova struttura coerente che a me ci sono voluti anni per realizzare.
Suppongo che se avessi fatto parlare gli hobbit in italiano, russo, cinese o altro, avrebbe lasciato i nomi come sono. […] Eppure in realtà in un paese e in un periodo immaginari come questi, creati con coerenza, la nomenclatura è un elemento più importante che in un romanzo “storico”. E ovviamente, se tralasciamo la “finzione” di un lontano passato, “La Contea” si basa sull’Inghilterra rurale e non su alcun altro paese del mondo, e fra tutti i paesi d’Europa meno di tutti l’Olanda, che è topograficamente del tutto diversa. (In effetti è tanto diversa che, malgrado l’affinità della sua lingua, e per molti aspetti dei suoi modi di dire, cosa che dovrebbe facilitare in parte il lavoro del traduttore, la sua toponomastica è particolarmente inadatta allo scopo.) Considerando il primo elenco, la toponomastica della Contea è una “parodia” di quella dell’Inghilterra rurale allo stesso modo in cui lo sono i suoi abitanti: le due cose vanno intenzionalmente insieme. Dopo tutto il libro è inglese, e scritto da un inglese, e presumibilmente anche chi desideri che la narrazione e la lingua siano convertiti in un idioma che comprende non chiederebbe a un traduttore di provare a distruggere deliberatamente tutto il colore locale. […]
Il Traduttore (a giudicare dal testo) ha dato un’occhiata alle Appendici, ma non le ha usate. […]
Il punto principale che non ha colto, ovviamente, è che anche quando il nome di un luogo è pienamente analizzabile da chi parla una lingua (e di solito non è così), questo di regola non viene fatto. Se in una terra immaginaria sono usati i nomi di luoghi veri, o attentamente costruiti per ricadere in schemi familiari, questi diventano nomi integrali, “suonano veri”, e tradurli in base al loro significato letterale è del tutto inopportuno. I nomi olandesi di questo Olandese dovrebbero suonare davvero olandesi. Io non sono in alcun modo un esperto di olandese, e conosco poco la peculiare storia della toponomastica olandese, ma non mi sembra che lo facciano. […]
Posso dire una volta per tutte che non tollererò in alcun modo un simile armeggiare con i nomi di persona. Né con il nome/termine hobbit. Non accetterò altri Hompen (su cui non sono stato consultato), né alcun Hobbel o altro.
[“Lettere 1914/1973”, J.R.R. Tolkien, a cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, traduzione di Lorenzo Gammarelli, Bompiani, 2018]
Insomma, una posizione molto chiara e apparentemente irremovibile. Tuttavia, Tolkien dovette riconoscere che qualche forma di traduzione era necessaria per la diffusione all’estero del suo libro; da qui nacque la necessità di scrivere la “Nomenclature of The Lord of the Rings”. Alla fine degli anni Sessanta, che è proprio il periodo in cui anche Vittoria Alliata si cimentò con la traduzione, Tolkien osservò:
[…] sembrerebbe che i ricercatori generalmente si confondano fra (a) il significato dei nomi interno, e appropriato, alla mia storia in cui appartengono a una costruzione “storica” fittizia, e (b) le origini o fonti nella mia testa, esterne alla storia, delle forme di quei nomi. Riguardo al punto (a) ovviamente hanno informazioni sufficienti, anche se spesso trascurano ciò che viene fornito. Mi dispiace, ma finché sono vivo non esiste alcun mio sostituto. Ho scritto un commento alla nomenclatura, a uso dei traduttori; ma il suo scopo è principalmente di indicare quali parole e nomi possono e dovrebbero essere tradotti nella l[ingua] della t[raduzione] che svolge la funzione dell’inglese nel rappresentare la l[ingua] c[orrente] del periodo, restando inteso che i nomi che non sono e non derivano dall’inglese moderno dovrebbero essere conservati senza cambiamenti nella traduzione, dato che sono estranei sia per la lc originale, sia per la lt. Sarebbe utile un onomasticon che dia il significato e l’etimologia di tutti i nomi, indicando le lingue a cui appartengono.
[“Lettere 1914/1973”, J.R.R. Tolkien, a cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, traduzione di Lorenzo Gammarelli, Bompiani, 2018]

Se in precedenza la cosa più importante era mantenere l’inglesità del libro, in un secondo momento questo aspetto è dunque passato in secondo piano, perlomeno per quanto riguarda i termini in inglese moderno. Non posso conoscere i motivi che hanno portato Tolkien ad ammorbidire la sua posizione, ma è possibile che, avendo utilizzato lo stratagemma letterario dello pseudobiblium, abbia riflettuto sul modo in cui veniva percepito “Il Signore degli Anelli” nelle culture straniere. Come sappiamo, Tolkien fingeva che il Libro Rosso di Bilbo e Frodo fosse esistito davvero, comportandosi come se lui ne avesse semplicemente tradotto la storia. All’inizio aveva preso in considerazione solo il pubblico inglese, essendo lui stesso inglese, molto affezionato alla sua patria e alla sua cultura; poi si sarà reso conto, immagino, che mantenere l’inglesità a tutti i costi poteva essere controproducente per preservare la finzione letteraria, creata da lui stesso, grazie allo pseudobiblium.
Veniamo quindi alla traduzione italiana. Premesso che non c’è una regola fissa per trattare i nomi, a maggior ragione se consideriamo che l’italiano non è una lingua germanica, chi traduce “Il Signore degli Anelli” ha due scelte fondamentali, da cui deviare quando e come lo ritiene necessario: tradurre tutti i nomi, eccetto quelli espressi nelle lingue inventate da Tolkien, oppure lasciarli tutti in originale. La prima scelta, se messa in atto sempre e comunque, comporterebbe anche l’adattamento fonetico di certi nomi che in italiano potrebbero suonare stranianti o problematici, come ad esempio “Bree” o “Archet” – che Tolkien, invece, suggerisce di lasciare invariati. Questa sembra essere stata la decisione di Alliata, che si era spinta fino a tradurre “Merry” con “Felice”.
Quirino Principe, dal canto suo, ha preferito una soluzione ibrida: determinate scelte di Alliata sono state considerate fuori tono, perciò alcuni nomi sono stati da lui riportati alla forma originale… ma non quelli che Tolkien aveva indicato di non tradurre. Sembra comunque che il curatore fosse intenzionato a mantenere l’inglesità, almeno per quanto riguarda i personaggi principali. Possiamo notare, infatti, che gli Hobbit “secondari” presenti nella narrazione, come quelli nominati alla festa di Bilbo, hanno cognomi tradotti (“Scavari”, “Serracinta”, eccetera), oppure adattati (“Bolgeri”). Fa eccezione “Boffin”, che dev’essere parso accettabile per il pubblico italiano (già da Alliata, suppongo). Un’altra eccezione è costituita dalla famiglia di Lotho, che mantiene il cognome – anzi, il doppio cognome – della versione originale, probabilmente perché include l’elemento “Baggins”, di cui Principe rifiutava la traduzione. I cognomi degli Hobbit che conosciamo meglio, invece, sono uguali agli originali, con l’unica differenza che la y di “Brandybuck” viene cambiata in i. Quanto a “Took”, troviamo la forma “Tuc”, scelta che immagino sia da attribuire ad Alliata, e ha lo scopo di avvicinare il termine alla fonologia della lingua italiana… ma non sembra comunque un termine italiano, quindi Principe non avrà ritenuto necessario intervenire.
Fatica ha seguito la stessa strada di Principe, ma nel suo caso è ancor più difficile rintracciare una coerenza nel lavoro. Nella versione modificata da Principe, si cerca appunto di mantenere l’inglesita degli Hobbit più importanti – quindi l’unica critica che si può fare è al trattamento riservato al personaggio di Peregrin. Nella versione di Fatica, inglese e italiano sono mescolati senza che si capisca dove si vuole andare a parare.
Come ha spiegato alcuni mesi fa Francesca Montemagno su Facebook, in traduttologia esistono i concetti fondamentali di “domesticazione” e “straniamento”, che vengono applicati a seconda delle intenzioni di chi traduce, rispettivamente per avvicinare il testo al pubblico della lingua di destinazione e per mantenere una maggiore distanza, richiedendo al suddetto pubblico qualche sforzo in più:
Domesticazione e straniamento possono essere applicati a vario livello […] ma nel nostro caso, ossia la traduzione dei nomi ne Il signore degli anelli […] è piuttosto semplice: un nome addomesticato compare in qualche misura italianizzato mentre uno straniato si presenta nella sua forma originale.
Un’eccessiva mescolanza di nomi originali e nomi tradotti, a mio avviso, rischia di infastidire o disorientare chi legge. Nella vecchia traduzione, per esempio, ho sempre trovato straniante che il capostipite della famiglia Vecchiobecco avesse cambiato il proprio cognome in “Brandibuck”. Forse è per questo che Fatica ha tradotto con “Vecchiodaino” e “Brandaino”… ma se poi devono esserci “Samplicio Gamgee” e “Peregrino Took” non è che le cose migliorino.
Ci sarebbe poi la seconda scelta che ho menzionato, quella di mantenere tutti i nomi in lingua originale. Personalmente la ritengo impraticabile, perché “Il Signore degli Anelli” è un libro ricchissimo di nomi, non solo di persone e di luoghi, ma anche di oggetti… Persino le spade hanno nomi! Già non è facile tenere a mente i termini espressi nelle lingue elfiche; se anche quelli in inglese moderno venissero lasciati invariati, si finirebbe per ubriacare il pubblico!
Per questo motivo, se fossi stata al posto di Principe, non avrei mai riportato “Baggins” e compagnia alla forma originale, soprattutto per i motivi da lui addotti. Voglio dire, posso capire la volontà di preservare l’inglesità, ma perché dire che il pubblico italiano non doveva prendersi troppa confidenza con certi personaggi eroici? Come se la lingua italiana si coniugasse male con l’eroismo, quasi fosse inadeguata per definizione a renderlo. Non dico che tutte le scelte traduttive di Alliata fossero le migliori possibili e andassero mantenute, però si potevano cercare ulteriori soluzioni in italiano. Che caspita, era pure il 1970! Se questa scelta fosse stata fatta negli anni Novanta o Duemila, già sarebbe stata più comprensibile…
Riguardo a Fatica, credo che in un certo senso sia arrivato troppo tardi. Dopo mezzo secolo, cercare di recuperare – anche solo in parte – un’italianità perduta nei nomi dei quattro Hobbit principali mi sembra infruttuoso. Per me, all’epoca della prima revisione della traduzione di Alliata, si è persa l’occasione di avere dei nomi più vicini alla cultura ricevente. Ormai non si può più tornare indietro; visto che la traduzione sedimentata nell’immaginario collettivo è quella con le modifiche di Principe, e che la Bompiani ha voluto mantenere inalterato “Baggins”, tanto valeva non toccare neanche “Brandybuck” e “Samwise”.
Se le cose fossero dipese da me, in passato avrei fatto tradurre “Baggins” e “Brandybuck”, mentre avrei fatto adattare foneticamente “Gamgee” e “Took”, esattamente come dice Tolkien nella guida alla traduzione. Alliata, per quanto ne so, aveva optato – oltre che per i già citati “Sacconi” e “Tuc” – per “Brandibucco” e “Gamigi”. A parte “Tuc”, penso che fossero scelte migliorabili; ad esempio si poteva scegliere “Brandibecco”, invece di “Brandibucco”, come hanno già suggerito altre persone prima di me, visto che il maschio della capra si chiama anche “becco”. È vero che c’è chi non lo sa… ma, per impedire che si pensasse al becco degli uccelli, sarebbe bastata una piccola nota del traduttore da inserire nel prologo (è lì che compare la prima volta il nome “Brandybuck”). Questo non avrebbe portato a trasformare “Buckland” in “Beccolandia”, perché si sarebbe potuto optare per un semplice “Terra del Becco”, che è più rispettoso della natura della lingua italiana e suona meno comico e infantile.
Per “Gamgee” un’altra possibilità era quella di adattarlo in “Gammigi”, che peraltro somiglia molto a “Gammidgy”, di cui “Gamgee” è una derivazione stando a quel che Tolkien dice nell’Appendice F.
“Sacconi” non mi piace particolarmente, però suppongo sia una questione di gusti. Provando a mettermi nei panni di Alliata, avrei optato per “Borsili”, che credo non esista, ma somiglia un po’ di più al termine originale e alle mie orecchie suona bene.
Quanto ai nomi propri, penso che avrei fatto tradurre “Peregrin” e adattare “Pippin” esattamente nello stesso modo scelto da Alliata; mentre avrei mantenuto sia “Meriadoc” sia “Merry”, che non sono nomi difficili e, anche se danno una sensazione di estraneità, appartengono a un abitante di Buckland (o Terra del Becco, se vogliamo!), quindi va bene se suonano un tantino diversi. Anche “Frodo” avrei preferito che restasse invariato, mentre “Samwise” non so. Lì il discorso diventa problematico, dato che “Samvise” può creare problemi di pronuncia e “Samplicio” tradisce un po’ troppo facilmente il significato del nome. Forse si poteva trovare qualche altro compromesso – e Alliata, se non sbaglio, aveva scelto un altro nome ancora, perché mi pare che “Samvise” sia stata un’idea di Principe. Non so, non mi viene in mente nulla che possa essere utile al caso.
Casomai un ritorno ai nomi originali sarebbe potuto essere messo in atto – includendo anche “Peregrin”, però – nel periodo dell’uscita della trilogia cinematografica, intorno al 2000. Può avere senso che, agli albori del nuovo millennio, quando l’inglese si sta diffondendo sempre più, si interpreti in chiave differente il rapporto tra pubblico italiano e nomi stranieri. L’edizione che ho io de “Il Signore degli Anelli” è del 2003, e credo che siano state apportate alcune modifiche proprio perché erano già usciti i primi due film. Non penso che ci siano cambiamenti significativi nella nomenclatura, rispetto a quelli che aveva già operato Principe a suo tempo; in caso qualcuno di voi ne sappia di più, suppongo che mi illuminerà in proposito. Comunque stiano le cose, quella del 2003 dovrebbe essere la prima edizione la cui traduzione è stata riveduta dalla STI… e la STI, se non ricordo male, ha collaborato anche con Francesco Vairano, direttore del doppiaggio e dialoghista, durante l’adattamento italiano della trilogia.
Proporre in quel periodo alcuni nomi in inglese mi sarebbe parso comprensibile e in linea coi tempi. Non dimentichiamo, peraltro, che i nomi propri dei quattro Hobbit non sono presenti nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, quindi scommetto che Tolkien avrebbe preferito che restassero invariati. E se negli anni Settanta si poteva pensare che il pubblico italiano rimanesse troppo straniato da “Samwise” (regolandosi di conseguenza), non credo potesse valere lo stesso discorso per gli anni Duemila. Nella versione cinematografica, inoltre, non c’è alcuna finzione letteraria da mantenere circa l’inglese moderno che traduce l’Ovestron, né è molto esplicito il ricorso allo pseudobiblium – quindi l’idea che abbiamo a che fare con una storia realmente accaduta, che in qualche modo è universale, si attenua tantissimo. Insomma, c’è meno bisogno di ricreare un senso di familiarità nel processo di adattamento dei film. E una nuova traduzione del libro – o una traduzione riveduta – realizzata in quel periodo avrebbe potuto provare a cambiare un po’ le cose, allontanandosi dalla più spiccata italianizzazione precedente. Non che fosse obbligatorio, sia chiaro; dico solo che avrebbe avuto senso voler provare. Ovviamente io posso dire tutto questo col senno del dopo, ne sono consapevole.
Non avrei comunque voluto – e non lo vorrei neppure oggi – che vent’anni fa ci si spingesse fino a riportare alla forma originale anche i nomi di luoghi, che secondo me sarebbero dovuti rimanere tradotti, sia nei film che nel libro. In fondo, sono proprio i nomi di luoghi quelli più facilmente evocativi in lingua originale, quindi mi sembra giusto che sia così anche in italiano. Diverse persone sostengono che ormai l’inglese sia parlato da tutti, che nessuna traduzione dei nomi sia necessaria… ma io non mi trovo d’accordo. I nomi della Terra di Mezzo non sono scelti a caso e portano sempre con sé delle implicazioni: hanno un significato che può essere immediatamente percepibile, oppure più recondito, ma toccano corde familiari per chi è madrelingua inglese e in qualche modo “sanno di già sentito” – tranne quando l’Autore ricerca volutamente un effetto diverso. Ecco perché, nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, Tolkien parte dal presupposto che i termini in inglese moderno dovrebbero essere tradotti: così facendo, il pubblico della lingua di destinazione può ambire a sperimentare delle sensazioni molto simili – non mi azzardo a dire le stesse – del pubblico della lingua di partenza. Un compromesso bisogna trovarlo, non si può pretendere che tutti i nomi originali siano evocativi per le lettrici e i lettori italiani come lo sono per le lettrici e i lettori inglesi.
Per quanto un/a italiano/a possa conoscere bene l’inglese (cosa che, peraltro, non è sempre vera per tutti), percepirà sempre l’italiano e l’inglese in maniera diversa… perché il linguaggio non è qualcosa di impersonale, e un/a italiano/a che abita in Italia parla la sua lingua ogni giorno, la respira, la “vive”. Perché c’è differenza tra la lingua inizialmente percepita come estranea, studiata e appresa col tempo, e la lingua che viene naturale usare, che fa dare istintivamente un nome alle cose. Perché, come dice la doppiatrice Chiara Colizzi citando Nelson Mandela, “parlare a qualcuno in una lingua che comprende consente di raggiungere il suo cervello; parlargli nella sua lingua madre significa raggiungere il [suo] cuore”.
°°citazione tratta da “La Compagnia dell’Anello”, J.R.R. Tolkien, traduzione di Ottavio Fatica, Bompiani, 2019
**citazione tratta da “Il Signore degli Anelli”, J.R.R. Tolkien, traduzione di Vicky Alliata di Villafranca, Bompiani, 2003
*citazione tratta da “J.R.R. Tolkien: la via per la Terra di Mezzo”, Tom Shippey, Marietti, 2005. Titolo originale dell’opera: “The Road to Middle-earth”. Traduzione italiana: Roberto Arduini, Giacomo Bencistà, Maria Raffaella Benvenuto, Cristina Cannizzo, Giampaolo Canzonieri, Marco Alessandro Ferraguti, Lorenzo Gammarelli, Massimo Giacomantonio, Alberto Ladavas, Francesca Lomello, Simone Petralli, Maria Luisa Rossetti, Chiara Sgro, Luca Volonteri. Il libro di Shippey mi è stato utile anche per i riferimenti all’etimologia dei nomi “Baggins” e “Frodo”, nonché alla pace di Fróthi (o “pace di Fróði”, com’è scritto in un interessante articolo reperibile su Internet, che parla dell’età dell’oro nella cultura indoeuropea).
Altre citazioni in italiano, quando non provengono dall’articolo del blog “Cercatori di Atlantide”, sono tratte dalle bozze dell’Appendice F de “Il Signore degli Anelli”, contenute in “The History of Middle-earth”, Volume XII, a cura di Christopher Tolkien (salvo dov’è espressamente indicata un’altra fonte). Tali bozze sono state tradotte e pubblicate sul sito italiano Eldalië.
L’edizione originale de “Il Signore degli Anelli” citata in questo articolo è la seguente: “The Lord of the Rings”, J.R.R. Tolkien, Houghton Mifflin Harcourt, 2004. Si tratta dell’edizione americana corredata da una nota introduttiva di Wayne Hammond e Christina Scull, studiosi e biografi di Tolkien, che hanno anche scritto il volume “The Lord of the Rings: A Reader’s Companion” (2005).
Le altre citazioni in inglese provengono dalla “Nomenclature of The Lord of the Rings” – che, ho scoperto, è scaricabile da Internet.
Proprio ieri sera stavo leggendo le lettere di Tolkien e in una indirizzata a Christopher spiegava proprio l’origine del nome Samwise. Esso deriva dall’antico anglosassone e in italiano va tradotto proprio Samplicio, da sempliciotto / sciocco. Così come il Gaffiere (Ham) sta per Casalingo.
Devo ancora procurarmi la nuova versione del Signore degli Anelli, ma da quello che ho visto posso dire che é molto più accurata nella traduzione dei nomi.
Come hai detto giustamente anche tu, sono più Italiani.
Capisco l’essere affezionati a quelli vecchi, io stesso continuerò a chiamare Samwise Sam e non Samplicio. Però, come te, non inorridisco di fronte alla nuova traduzione. E come te mi stupisco dei fan che lo fanno, visto che questa é più precisa di quella vecchia 😅
"Mi piace"Piace a 1 persona
“In italiano va tradotto proprio Samplicio”… In realtà, in questo articolo, ho proprio sottolineato le criticità della scelta di tradurre con “Samplicio” XD Non è che sia sbagliata, ovviamente, ma non mi sembra certo la migliore delle soluzioni… e mi sembra di averne abbondantemente spiegato i motivi…
Che la versione di Fatica sia generalmente più accurata nella traduzione dei nomi può essere (vedi esempi come “Quartiero”). Tuttavia bisogna vedere il risultato complessivo – e personalmente trovo che lasci a desiderare. Infatti non comprerò i prossimi volumi, per me l’ “avventura” con la nuova traduzione finisce qui.
Riguardo ai fan che inorridiscono, penso che per alcuni si tratti di reazioni di pancia, mentre altri immagino siano semplicemente fanatici. C’è da dire che questa nuova traduzione è stata presentata in modo molto… come posso dire, “antipatico”? Ma non mi dilungo oltre su questo, visto che ne ho già parlato nel mio articolo.
"Mi piace"Piace a 3 people
Grazie per aver condiviso le tue riflessioni ed osservazioni, cara Elle. Come prima, continuo a pensare che è tra le migliori analisi “contro” che si trovano in rete. Per rispondere a tutto che hai scritto ci vorrebbe un saggio. Mi limito solo a un’opinione molto generica. Mi dispiace che Fatica ha optato per una soluzione ibrida, come Principe prima, lasciando alcuni nomi senza traduzione o adattamento fonetico. Ma la traduzione dei nomi è una questione troppo spinosa e l’elemento soggettivo dei gusti personali è fortissimo nel giudicare. Per quanto possa essere precisa ed azzeccata la traduzione proposta, ci sarà sempre qualcuno che la troverà orrida. È impossibile accontentare tutti. E sorge anche la domanda, se un traduttore deve considerare l’opinione di tutti. Sul resto, come promesso, non mi pronuncio.
"Mi piace"Piace a 2 people
Quello della nomenclatura è un lavoraccio! Io ho selezionato solo alcuni nomi, e guarda quant’è venuto lungo l’articolo XD Chiunque si cimenti con la traduzione italiana dell’opera tolkieniana ha tutta la mia solidarietà – anche perché una vera e propria soluzione non esiste. O si traducono e si adattano tutti i nomi, tranne quelli espressi nelle lingue inventate da Tolkien, oppure si lasciano tutti in originale. Nel primo caso, si finisce inevitabilmente per contravvenire ad alcune indicazioni dell’Autore, per esempio quelle riguardati “Bree” e “Archet”; nel secondo caso, si rende il testo molto più difficile e si toglie al pubblico italiano la possibilità di percepire le suggestioni contenute nei nomi (specialmente i nomi di luoghi). Insomma, come fai sbagli.
Riguardo a Fatica, personalmente non lo colpevolizzo per le sue scelte di nomenclatura. Innanzitutto perché sono motivate (come sicuramente quelle di Alliata e di Principe), anche se queste motivazioni talvolta appaiono oscure, inspiegabili, o semplicemente sono discutibili. Io non so perché Fatica abbia scelto “Montagna Fiammea” – e quand’anche lo sapessi, non è detto che condividerei le motivazioni del traduttore. Però dubito molto che abbia fatto questa cosa perché gli girava così. Purtroppo, Fatica si è ritrovato a lavorare in un momento difficile, perché ormai i nomi della vecchia traduzione fanno parte dell’immaginario; suppongo sia per questo motivo che Bompiani non ha voluto che venisse tradotto “Baggins”. A quel punto, però, visto che anche “Pippin” e “Took” sono stati lasciati invariati, tanto valeva non toccare nemmeno “Brandybuck”, “Peregrin” e “Samwise”, per evitare disarmonia almeno tra nome e cognome dello stesso personaggio.
Per me, l’occasione di avvicinare di più “Il Signore degli Anelli” alla cultura italiana è ormai andata persa mezzo secolo fa. Alliata ci aveva provato, ma la primissima edizione de “La Compagnia dell’Anello” ha venduto pochissimo. Poi è arrivato Principe, ha fatto le sue modifiche – alcune positive, a mio parere, ma altre no – ed è stato quello che è stato. Avrei preferito di gran lunga una buona italianizzazione allora, cambiando alcune scelte di Alliata, ma mantenendo comunque lo stesso approccio al trattamento della nomenclatura (avvicinarsi alla lingua di destinazione). Davvero un peccato che non sia andata così!
Grazie per il commento, se vuoi aggiungere qualcosa sentiti sempre libera di farlo 🙂
"Mi piace"Piace a 2 people
Riguardo all’accontentare tutti, ovviamente non è possibile. Ogni traduzione ha i suoi limiti e chi traduce non è una divinità. Però trovo che Fatica, in diverse occasioni, si sia comportato come se l’italiano fosse l’inglese (vedi “Colbree”!). E, per rovesciare l’affermazione di Gandalf, questo NON può essere un pensiero incoraggiante…
"Mi piace"Piace a 2 people
Un’analisi davvero dettagliata. Sembra proprio che tu abbia un talento naturale verso la comparazione linguistica. L’unico elemento che posso apportare alla tua appofondita disamina riguarda il passaggio dalla traduzione di Alliata-Principe a quella del 2003; se non sbaglio, fu in quella circostanza che scomparvero alcuni termini come «Orchetti» e «Vagabondi»; se il primo era tutto sommato abbastanza intuibile (designava, cioè, gli orchi di più piccole dimensioni), il secondo era francamente incomprensibile. È vero che i Troll non hanno residenza stabile, ma non vedo perché dovevano essere identificati con dei generici vagabondi…a quel punto era persino preferibile il nome «Uomini neri» dell’Hobbit che almeno rievocava alcune creature del folklore europeo che vivono nei boschi e si cibano di carne umana…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie mille per i complimenti, è molto bello sapere di essere stata capace di fare un buon lavoro, pur non essendo assolutamente un’esperta 🙂
Grazie anche per le tue segnalazioni. Le modifiche di cui parli devono essere opera della STI, che per l’appunto dovrebbe anche aver collaborato all’adattamento italiano dei film. “Vagabondi”, in effetti, è proprio tirata per i capelli come traduzione… Probabilmente si pensava che “Troll” non avrebbe avuto alcun significato per il pubblico italiano, ma forse a quel punto era meglio tradurre con “mostri di montagna” o roba del genere (come nella mia edizione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, dove “troll” è tradotto con “mostro”).
"Mi piace"Piace a 2 people
Già…oppure con “Giganti” (anche se questo termine era stato già applicato nello Hobbit per indicare creature di origine diversa rispetto ai Troll).
"Mi piace"Piace a 1 persona
Da queste tue riflessioni si potrebbe senza troppa difficoltà ricavare un vero e proprio saggio sulle difficoltà della traduzione del Signore degli Anelli. Ho appreso tante cose che ignoravo, sia per quel che riguarda le etimologie dei nomi Hobbit sia a proposito delle indicazioni di Tolkien stesso.
Quanto alla battuta su Frodo e le frodi, è stata alla base di tanti giochi di parole e parodie italiane, e a me continua a fare ridere. Detto ciò, ovviamente il nome è ormai diventato iconico e tradurlo non avrebbe il minimo senso. Non sapevo però dell’origine germanica: è davvero affascinante.
In sostanza, concordo con la parte finale delle tue riflessioni, ovvero, trovo che avrebbe avuto senso cercare una traduzione di Baggins, Brandybuck, Gamgee e Took negli anni Settanta, ma già dal 2000 sarebbe risultato superfluo, se non ridicolo. Vero è che io non avevo mai collegato il cognome di Meriadoc ai daini, causa anche la mia limitata conoscenza della lingua inglese. Mentre il collegamento fra Baggins e Sackville e le borse è sempre stato chiaro.
Tradurre è sempre un po’ tradire, come si dice, ed è naturale che alcuni significati vadano perduti o restino oscuri. Purtroppo, certo.
D’altra parte, nelle traduzioni inglesi dei Promessi Sposi traducono forse i cognomi Mondella e Tramaglino, per dare l’idea del “mondare” e di una rete da pesca (“tramaglio”)? Onestamente non lo so.
In ogni caso, l’arroganza, o meglio, la spocchia (grazie per avermi offerto questo termine!) di Fatica è ormai un fatto consolidato e rende assai difficile cercare di essere indulgenti verso certe sue scelte, almeno per me. Non si può prima fare Capitan Fracassa e poi cascare di sella da un Cavallino Inalberato.
Al contrario, ho notato che tu sei riuscita a scindere i due aspetti, come è giusto che sia, e ciò è senz’altro il maggiore punto di forza di tutta la tua analisi. Oltre al fatto che, come ho scritto sopra, quello che hai fatto tu è un lavoro di confronto delle traduzioni estremamente preciso, e quasi filologico.
Peccato che per scrivere simili testi argomentati e seri ci voglia tempo, per lo studio e le analisi, mentre per insultare non ci vogliano che pochi secondi.
"Mi piace"Piace a 4 people
“Non si può prima fare Capitan Fracassa e poi cascare di sella da un Cavallino Inalberato”… Questa è bellissima, me la appunto!
Grazie mille per i complimenti, è un onore sapere che il mio articolo potrebbe essere una buona base per un saggio 🙂 Mi sono impegnata al massimo, quindi mi rende felice sapere che il risultato è un’analisi precisa – non filologica, ovviamente, perché non ho queste pretese, ma precisa vuol dire già molto!
Riguardo a Frodo, conoscevo da diverso tempo l’origine del suo nome. Devo dire che l’idea di tradurlo con “Savio” non è così malvagia… È un po’ come rendere “Samwise” con “Samplicio”: il senso è corretto, solo un po’ troppo esplicito. Per me “Frodo” non è un nome da tradurre, proprio perché anche in originale il significato non è immediato. Non l’avrei tradotto neppure negli anni Sessanta o Settanta – e non sono così sicura che Alliata l’abbia fatto, anche perché il nome proprio di Frodo non è citato nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, tantomeno nell’Appendice F, ma solo nelle bozze di quest’ultima, che certo all’epoca non erano disponibili. Resta però il fatto che, per noi italiani/e, rimanda al termine “frode”… e su questo non possiamo farci niente. È uno di quei casi in cui l’arte della traduzione mostra chiaramente i propri limiti. Ecco, avrei preferito di gran lunga che Fatica sottolineasse queste cose (nessuno dovrebbe saperle meglio di un traduttore), invece di “difendersi” dicendo che Tolkien non era del tutto coerente coi nomi e quindi neppure lui può esserlo…
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ah, guarda, quando ho letto qui che Fatica si era messo a criticare Tolkien per giustificare il suo lavoro sotto certi aspetti mediocre, quasi non riuscivo a crederci. Dai, ma chi lo difende a spada tratta, come fa ad accettare Colbree che non vuol dire proprio nulla? O anche Boscuro, che suona abbastanza male?
Hai fatto un’osservazione davvero intelligente quando hai notato che inglese (e ancor più tedesco) sono lingue dove l’unione di diverse parole è naturale, mentre in italiano non lo è, in linea di massima. Fortuna che ci è stata risparmiata “Mezzoterra”, o mi sarei ammazzato dalle risate. Anche se pure con Forestali ho riso parecchio.
"Mi piace"Piace a 1 persona
“Forestale” è stato giustificato in tutti i modi possibili da Wu Ming 4, ma a me continua a sembrare una scelta inefficace. Sicuramente tradurre “Ranger” è molto difficile, ma se il risultato è quello di straniare o far ridere gran parte del pubblico, forse bisogna farsi qualche domanda…
“Boscuro” è meglio, almeno non ti fa lo stesso effetto. “Colbree” lo trovo indifendibile, sinceramente.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ma che bell’articolo! 😍
È valso senz’altro l’attesa – così come l’enorme lavoro di ricerca che c’è stato dietro! 🙂
Nonostante su gran parte della trattazione fossi già informato, ho potuto comunque apprendere qualcosa di nuovo. E soprattutto ho apprezzato il tuo stile critico, nel senso positivo del termine (quello di pensiero critico, spirito critico, critica costruttiva e non distruttiva). Ho apprezzato molto anche la premessa.
C’è tantissima carne al fuoco ed è impossibile rispondere a tutto, ma vorrei comunque contribuire corroborando una tua osservazione: tra i campi semantici di “big” ci può sicuramente essere anche quello riferito alla statura, quando l’aggettivo è rivolto ad una persona. D’altronde, si può essere “grande” sia in altezza che in larghezza – mentre “grosso” è riferito più specificatamente a quest’ultima accezione, essendo una traduzione più letterale di “large”. Se proprio si dovesse scegliere di tradurre in maniera più specifica, sarebbe meglio concentrarsi su “tall”: agli occhi degli Hobbit, parlando in generale, gli Uomini risaltano indubbiamente più per l’altezza che per robustezza. Per questo, alla fine della fiera, penso che “Gente Alta” sia una scelta più naturale anche rispetto alla traduzione che sarebbe più letterale, “Gente Grande”. Anzi, mi sembra proprio uno di quei casi in cui traducendo letteralmente di commette un’imprecisione – un po’ come (con le dovute proporzioni, perché qui sto volutamente esagerando) tradurre “hai ragione” con “you have reason” invece di “you’re right”.
"Mi piace"Piace a 2 people
Grazie per l’apprezzamento! Sono molto contenta di averti fatto apprendere qualcosa di nuovo 🙂 Grazie mille anche per il contributo che hai offerto, riguardo alla traduzione del vocabolo “big”.
Quanto al resto, diciamo che per me ci voleva. Non mi piace questa situazione in cui sembra che ci si debba schierare per forza, proprio perché il rischio è quello di operare una divisione netta tra chi ha ragione e chi ha torto, chi ha fatto la cosa giusta e chi ha fatto la cosa sbagliata. La realtà è complessa e gli errori, a mio avviso, ci sono stati da entrambe le parti… Ecco perché ho voluto aggiungere delle osservazioni critiche che andassero oltre l’aspetto linguistico della questione.
"Mi piace"Piace a 2 people
Ciao! Fantastico articolo, che colpevolmente abbiamo trovato solo adesso, perché da settimane siamo blindati a scrivere il post che abbiamo pubblicato oggi. Giuriamo di non averti copiato in commenti come quello sulla Grossa Gente! Great minds think alike… Adesso la mamma ci sta chiamando a cena e si rischia una strage, ma torneremo per rileggere con calma e commentare, anche i commenti 😀 Buona Pasqua a tutti!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie, buona Pasqua anche a voi feanoriani 😉 Per quanto riguarda “Grossa Gente”, mi stupirei se le persone non ne parlassero, visto che suona forzatissimo!
Vi aspetto per un commento futuro, quando avrete un po’ di calma 🙂
"Mi piace"Piace a 1 persona
Possiamo adottarti come sorellina meno pazza di noi? Grazie dell’atteggiamento pacato e super partes nell’affrontare la spinosissima questione della diatriba ideologica. Che porta con naturalezza all’atteggiamento discutibile di Fatica e dell’AIST. Importantissimo il concetto di “valore storico” della traduzione A/P, ridotta dai Nostri a “orsacchiotto di peluche”. Le dichiarazioni di Fatica, o quelle di chi riferisce le sue parole, oltre a essere spesso offensive, contengono moltissime contraddizioni ed errori. Qualcuno lo abbiamo segnalato nel nostro recente post sul Prologo. Tu ce ne hai fatto scoprire uno nuovo, quello di Merry che secondo Fatica NON dovrebbe far pensare a “felice”. Quelle parti dell’articolo le avevamo lette di fretta perché, come sai, non volevamo concentrarci per prima cosa sui nomi. Ora le rileggeremo con più attenzione!!! Hai notato poi che Fatica o chi per lui, nei resoconti degli incontri di Parma e Modena, confonde regolarmente Harrowdale e Dunharrow?
Sulla nomenclatura condividiamo praticamente tutto del tuo capillare lavoro! Abbiamo scoperto cose nuove (che forse non volevamo sapere). Vallea per Dale lo troviamo bello, sia come suono che come significato ampio e solenne. Ma usarlo come termine generico per “valle” è terribile. “Vallea Morgul”??? Oltre a tutto è lo stesso problema che c’è nel film quando si parla di “pugnale Morgul”. Si prende per aggettivo quello che è un nome: dovrebbe essere “pugnale di Morgul”, “Valle di Morgul”. Non ci piace neanche la “Vallea dei Riombrosi” (Dimrill Dale). E hai notato che nel I capitolo, a metà del discorso di Bilbo quando i giovani hobbit giocano con i petardi, questi recano la scritta VALLE???
Su “Selvalanda” stavamo per sparare a zero, perché non ci sembrava che ci fossero selve in “Wilderland”; la tua spiegazione ha molto senso, e inoltre (ancor prima di leggerla) ci siamo fermati in tempo perché abbiamo scoperto che in “wilder” compare per vie traverse “wald” = bosco! Non riusciamo a copiare qui il link, ma lo trovi in fondo al nostro post sul Prologo: è tratto dal libro “The Ring of Words: Tolkien and the Oxford English Dictionary”.
Per la fonte di Frodo = Savio, hai provato a cercare in “Tolkien e l’Italia” di Oronzo Cilli? Anche a noi suona familiare.
COLBREE??? No, non volevamo saperlo. Grazie per averci ricordato cosa dice Tolkien riguardo a Chet, Archet e Bree: nel nostro post abbiamo commesso un errore, ora corretto. Forse abbiamo anche confuso nomi univerbati con nomi composti. Purtroppo ci manca una base di studi linguistici: sappiamo cosa vogliamo dire ma non abbiamo i termini per dirlo! Stiamo imparando, anche grazie a te.
Sei per caso in contatto con noi su FB? Abbiamo perso il filo… Se non lo sai, venerdì 17 alle 21 saremo virtualmente in radio sulla Voce di Arda (http://www.spreaker.com/user/simoneclaudiani), tramite Paola Cartoceti, per parlar male di Fatica :DDD
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ciao a tutti! Non so se riuscirò a seguire la radio, ma intanto vi ringrazio per la segnalazione 🙂 Non credo di essere adatta a ricoprire il ruolo della feanoriana, sono solo una piccola Hobbit 😀 😉 Comunque è molto carino da parte vostra considerarmi una di voi!
La diatriba ideologica è davvero un affare spinoso – e, per quanto mi riguarda, è inutile che Fatica e l’AIST si facciano/vengano fatti passare come le vittime della situazione, perché non lo sono. Hanno i propri torti (anche se suppongo che non li ammetteranno mai), indipendentemente dal modo in cui Alliata, la STI o chiunque altro possa aver agito. E la cosa dell’ “orsacchiotto di peluche” è fastidiosa, non solo perché così viene sminuito il valore che ha la vecchia traduzione (pur con i suoi difetti e i suoi limiti), ma perché mina la complessità del dibattito, riducendo tutto a una banale contrapposizione tra chi apprezza la nuova traduzione e chi non la apprezza solo perché fissato/a con i nomi della vecchia.
La questione Harrowdale/Dunharrow non l’avevo notata. Ammetto di aver volutamente escluso “Dunharrow” dalla mia analisi della nomenclatura, perché ho cercato di concentrarmi su quelli che sono i nomi più importanti ne “La Compagnia dell’Anello”, indipendentemente dal rilievo che possono avere nei volumi successivi. Per quanto riguarda Merry, non so se è stato Fatica a dire che bisogna leggerlo senza pensare ad “allegro”; potrebbe trattarsi di un’osservazione di chi ha fatto il resoconto dell’incontro a Parma. Resta comunque un’affermazione fuorviante, rispetto a ciò che dice Tolkien nell’Appendice F.
“Vallea Morgul” non mi entusiasma per vari motivi; sapete dirmi se “vale”, in inglese, è un termine ricercato?
Non possiedo il libro di Cilli, né l’edizione Astrolabio de “La Compagnia dell’Anello”, quindi non posso controllare un’eventuale traduzione del nome di Frodo! Mi sembra un po’ strano che Alliata possa averlo tradotto, per il semplice fatto che non ha un significato immediato, al contrario per esempio di “Merry”; e, sempre al contrario di “Merry”, non viene menzionato tra i nomi hobbit dell’Appendice F. A meno che Alliata non conoscesse l’etimologia germanica di “Frodo”, non credo che si sarebbe spinta a tradurlo – anche perché, a livello di pronuncia o di grafia, non crea alcun problema al pubblico italiano. Ad ogni modo, se avete informazioni precise in merito, magari potreste riferirmele.
Su “Colbree” non faccio commenti, mi sembra di aver già detto abbastanza 😀
“Stiamo imparando, anche grazie a te”… Oh, mamma mia, dov’è la faccina che arrossisce? Badate bene, non ho una formazione linguistica, più che altro ho fatto affidamento sui vocabolari (e su alcune affermazioni di chi traduce per professione). Per un’eventuale differenza tra nomi univerbati e nomi composti, andrò a documentarmi 🙂 Comunque, una cosa è certa: l’italiano non è una lingua agglutinante come l’inglese, eppure Fatica si comporta spesso come se lo fosse. Anche nella versione di Alliata troviamo certe cose, come “Trombatorrione”, “Pietracasa”, eccetera… ma ci sono altri casi in cui si è scelto di spezzare il toponimo, con ottimi risultati (“Bosco Atro”, “Terre Selvagge”). Poi è chiaro che c’è caso e caso… “Valforra” di Fatica mi sembra una buona scelta e, come altre ancora di Alliata (“Serracinta”, ad esempio), dimostra che non sempre i nomi vanno spezzati. Secondo me, non ha molto senso dire che per rimanere coerenti bisogna univerbare tutti i nomi, perché l’importante è ottenere risultati soddisfacenti, con termini – che a volte possono essere univerbati, a volte no – capaci di rispettare il significato originale e di suonare il più possibile naturali, se così si può dire. Ora, ditemi voi se “Colbree” suona naturale in italiano…
Non sono su Facebook, quindi non vi posso seguire lì. Però continuerò a leggere il vostro blog, non dubitate. A presto!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Come sempre equilibrata e pacata, grazie! Adesso stiamo riorganizzando il blog inserendo le Pagine, dove verranno raccolte e attribuite con precisione le principali citazioni di Fatica e dei commentatori senza che si debba andare a scavare in tutto il blog.
Riguardo a Frodo = Savio, abbiamo controllato e non sembra che la spiegazione si trovi in “Tolkien e l’Italia”. L’unico riferimento è nel resoconto dell’intervento di Fatica a Parma su https://www.cercatoridiatlantide.it/ottavio-fatica-parma-nuova-traduzione-il-signore-degli-anelli/ Forse ne sapremo di più quando avremo sbobinato tutto il contenuto della registrazione di Modena.
Idem per Merry: nella stessa pagina, la commentatrice riferisce “secondo Tolkien bisogna leggere merry senza pensare ad allegro. Infatti, merry è solo una riduzione di Meriadoc e andrebbe, secondo il Professore, ritenuta come priva di significato al momento della traduzione.” In realtà, nelle Appendici del SdA, Tolkien dice, parlando dei nomi originali degli hobbit: “Meriadoc was chosen to fit the fact that this character’s shortened name. Kali, meant in the Westron ‘jolly, gay’, though it was actually an abbreviation of the now unmeaning Buckland name Kalimac.” Quindi sì, Merry = allegro.
“Vale” non ci risulta ricercato, si può tradurre con valle o vallata a seconda del contesto.
Gasp! Speriamo che tutto ciò sia comprensibile…
"Mi piace""Mi piace"
Eccomi di nuovo!
Su Frodo, ho finalmente trovato la risposta. Non esiste alcun “Savio” nella primissima traduzione di Alliata, potete verificarlo voi stessi a questo link: http://glihobbitdibiblioteca.blogspot.com/2016/03/la-compagnia-dellanello-astrolabio-il.html?m=1
Sulla quarta di copertina compare il nome “Frodo” 🙂 Peraltro, so che un altro blogger è riuscito a mettere a disposizione l’intero primo capitolo dell’edizione Astrolabio (che io sarò lieta di leggere con calma appena ne avrò la possibilità), quindi il mistero è risolto! Resta da vedere se è stato Fatica a dire l’inesattezza sul nome del Portatore dell’Anello, oppure se chi era presente durante l’incontro a Parma ha equivocato. Per inciso, non c’era bisogno che metteste il link al resoconto di quell’evento, dato che, in questa terza parte del mio articolo, avevo rimandato proprio al blog “Cercatori di Atlantide” (sebbene tramite la pagina Facebook dell’AIST).
Anche per quanto riguarda Merry, io stessa ho citato le frasi riportate su “Cercatori di Atlantide” e le ho confutate. Semplicemente, non è chiaro se sia stato Fatica a dire – sbagliando – che bisogna leggere Merry senza pensare ad “allegro”, oppure se questa sia farina del sacco di chi ha fatto il resoconto dell’evento.
Per la precisazione su “vale”, vi ringrazio molto 🙂 Invece riguardo a composizione e univerbazione, ecco dei link utili:
http://www.treccani.it/enciclopedia/composizione_(Enciclopedia-dell'Italiano)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/univerbazione_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/
"Mi piace"Piace a 1 persona
Mi inchino umilmente e mi scuso dell’assenza così prolungata da questo meraviglioso sito. Dall’ultima volta che sono passato sono successe fin troppe cose, di cui questa pandemia è solo l’ultima nella lista.
Per completare al meglio la mia conoscenza e i ricordi ho riletto la prima parte, e per amor della semplicità e della facilità di risposta commenterò la seconda e la terza qui.
Parlando della seconda, e in particolare come scrittore, so quanto la scelta del linguaggio usato, anche in base alla persona che sta parlando, sia estremamente importante ai fini di come il lettore riceve il messaggio.
Poi se si parla di traduzione dall’inglese all’italiano di certi termini, che dire? Dea dammi una mano.
E come sempre si passa agli Hobbit campagnoli che usano termini latino-greci che persino l’Accademia della Crusca ha dimenticato.
Ma passiamo all’argomento più scottante del momento. Ok sono passati mesi ma finché usciranno nuove edizioni sarà sempre il momento scottante.
I nomi.
Dirò mettendo le mani avanti che dopo anni e anni a vedere i film di Jackson, quelli animati, a giocare ai videogame e a leggere quel mattone di libro, due volte, una parte di me ha pianto solo per il semplice fatto di aver visto cambiare nomi che conoscevo da quando ero un pargoletto con manie di dominio del mondo.
Ma d’altra parte posso capire che ora che siamo in un’età “moderna” si senta questo bisogno di mostrare il messaggio originale dei nomi creati da Tolkien. Anch’io come scrittore vorrei che i nomi che creo giungessero al pubblico con la stessa idea con cui li ho scritti.
Purtroppo esiste un problema.
L’Italiano non è l’inglese e l’inglese non è l’italiano.
Ci sono termini che non possono essere tradotti letteralmente, e nei casi in cui si possono tradurre al meglio c’è il rischio che suonino orribili alla lettura o che sconvolgano il significato della cosa/persona/luogo con quel nome.
Per fare un esempio: Bosco Atro non sarà la traduzione esatta di Mirkwood, a parte la questione delle due parole separate (Hanno fatto la stessa cosa coi castelli delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e nessuno si è lamentato.) ma come impatto di lettura e uditivo mi fa pensare a un bosco contorto, tetro, insomma un posto tutt’altro che allegro.
Boscuro mi sembra un paesino lombardo.
E per quanto mi riguarda il Cavallino Inalberato, personalmente condivido il pensiero di Caleel, ovvero che sembra una parodia. Inalberato poteva anche starci (anche se a un pubblico medio-basso sembra più un cavallo bloccato su un albero) ma cavallino lo rende ridicolo.
Aggiungo che io personalmente nomi e cognomi li avrei lasciati completamente in lingua originale. I luoghi sono già più aperti e cambiabili, nomi e cognomi no.
Ovviamente questo è solo il mio pensiero e non forzo nessuno a pensarla come me.
Chiedo ancora scusa per la lunga assenza e dico che proverò ad essere più presente.
Bye bye.
-La Follia mi scorre nelle vene
"Mi piace"Piace a 2 people
Ciao, bentornato! Non preoccuparti per l’assenza, il blog è sempre qui… e del resto, pure io in questo periodo sono “assente” (non sto scrivendo articoli nuovi, anche se rispondo comunque ai commenti che vengono lasciati ai vecchi).
La questione della traduzione è, come sai, molto complessa. In linea generale, posso essere d’accordo sul fatto di mantenere nomi propri e cognomi in lingua originale – e suppongo che Tolkien concorderebbe, perlomeno se ci basiamo su ciò che dice nella sua lettera degli anni Cinquanta. C’è un problema, però… e da lì, immagino, nasce l’esigenza di stilare la guida per i traduttori: i nomi di Tolkien sono nomi “parlanti”, perché comunicano sempre qualcosa a chi è madrelingua inglese, che si tratti di un significato vero e proprio o di un semplice senso di familiarità, oppure di entrambe le cose (a parte quando il Professore ricerca volutamente un effetto un po’ straniante). Come fa il pubblico italiano a vivere questa esperienza? Il fatto che la gente oggi sappia l’inglese – cosa vera fino a un certo punto, fra l’altro – non risolve il problema, perché qui è questione di radici culturali, non semplicemente di “sapere” una lingua. Per questo motivo, la traduzione cerca di ricreare in italiano l’effetto che i nomi originali sortiscono in inglese. Ovviamente ciò non è sempre possibile, proprio per le ragioni esposte da te (“Ci sono termini che non possono essere tradotti letteralmente, e nei casi in cui si possono tradurre al meglio c’è il rischio che suonino orribili alla lettura”)… ma, poiché Tolkien stesso ha lasciato delle indicazioni, bisogna almeno provare a seguirle.
Per quanto mi riguarda, se fossi vissuta negli anni Sessanta-Settanta, suppongo che avrei fatto lo stesso ragionamento di Vittoria Alliata. Certo, credo che lei abbia esagerato a tradurre “Merry” con “Felice”, e che alcune sue scelte traduttive lascino a desiderare, ma comprendo quale sia stata la ragion d’essere del suo lavoro – e fondamentalmente la condivido. Più difficile mi riesce comprendere Principe, con il suo desiderio di non far prendere al pubblico italiano troppa confidenza con i Baggins. O Fatica, che mescola nomi italiani e nomi inglesi in maniera inspiegabile – almeno per quello che riesco a giudicare – e l’unica risposta che dà è che “sui nomi non è coerente nemmeno Tolkien”. Tutto questo dopo che la sua traduzione ci era stata presentata come “finalmente all’altezza dell’opera originale”.
Ad ogni modo, nel 2020 e dopo più di mezzo secolo che la versione modificata da Principe ha plasmato l’immaginario, io sarei andata piano con i cambiamenti. “Boscuro” sinceramente mi pare uscito dalla Melevisione, anche se il significato è corretto XD “Cavallino Inalberato” suona ridicolo proprio perché i due termini scelti stridono tra loro. Poi, vabbè, purtroppo ci sono anche controversie legali in mezzo, quindi è possibile che Fatica si sia visto costretto a operare determinati cambiamenti… ma ciò non toglie che i risultati siano spesso discutibili. E non toglie che in alcuni casi si potesse fare di meglio – indipendentemente da quanto le persone fossero legate ai vecchi nomi.
Quello dei registri linguistici è un altro tasto dolente. Tanto chiasso perché Alliata non li aveva rispettati – il che non è del tutto vero, peraltro – e poi, nella versione di Fatica, ci ritroviamo gli Hobbit che paventano il discorso postprandiale, “manducare” e “genìa” in bocca a Sam e suo padre, Elrond che esclama “vacci piano” e Gandalf che dice che si è “sciroppato” Gollum. La nuova traduzione può piacere o meno, ma una cosa è certa: tra ciò che si diceva per pubblicizzarla e ciò che si è rivelata essere in realtà, una differenza c’è…
Grazie per il tuo commento e per i tuoi complimenti 🙂
"Mi piace"Piace a 1 persona
Grazie mille per i link! Sì, noi spargiamo link a piene mani anche quando non è necessario; è la paranoia di FB, dove basta dire una cosa che subito qualcuno risponde “Ma dove è scritto?” (e poi non è d’accordo lo stesso). 😀
In effetti abbiamo anche noi il testo di Astrolabio che quel benemerito ha digitalizzato, ma non lo abbiamo ancora studiato, e ci viene in mente solo ora che comunque lì Frodo è Frodo. Può darsi che, con Savio, Fatica si riferisca a una scelta di Alliata ancora in fase di lavorazione, che poi non è stata tenuta. Ma non riusciamo proprio a trovare la fonte.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Posso capire la paranoia, anche se non sono su Facebook 😀 Ad ogni modo, sarebbe il caso che qualcuno segnalasse a “Cercatori di Atlantide” le inesattezze dell’articolo sull’evento di Parma, perché – che le abbia dette Fatica o che siano da attribuire a chi ha fatto il resoconto – di inesattezze si tratta.
Tornando a Frodo: l’articolo sostiene che il nome del Portatore dell’Anello sia stato riportato alla sua forma originale da Quirino Principe… ma, se nell’edizione Astrolabio c’è scritto “Frodo” e non “Savio”, ciò non è possibile, poiché Principe ha messo mano a “Il Signore degli Anelli” solo quando il testo è passato alla Rusconi! Inoltre, ammettendo che si trattasse di una scelta “in fase di lavorazione, che poi non è stata tenuta”, come suggerite voi, è davvero possibile che Fatica – o chi per lui – ne sia a conoscenza? Quale sarebbe la sua fonte? Avete detto che non se ne trova traccia in “Tolkien e l’Italia” – che, per quanto ne so, è l’unico testo che ricostruisce la storia editoriale italiana de “Il Signore degli Anelli” con documenti dell’epoca. La corrispondenza tra Tolkien e Alliata non è disponibile, quindi non si possono attingere informazioni da lì. L’unica fonte rimasta, a questo punto, è Alliata stessa. Vi risulta che abbia affermato di aver tradotto “Frodo” con “Savio”? A me no. Se poi dovesse saltare fuori un’intervista o un convegno in cui l’ha detto, sarò lieta di fare un passo indietro e dare ragione a Fatica, o a chiunque abbia dichiarato la cosa. Fino a prova contraria, però, quello che c’è scritto nell’articolo di “Cercatori di Atlantide” resta un’affermazione fuorviante e non supportata da alcuna fonte. Se volete la mia opinione, sono incline a credere che Fatica abbia preso una cantonata, confondendosi con “SaMio” (il nome che, nella primissima versione di Alliata, sostitutiva “Sam”), e che l’autrice dell’articolo non si sia presa la briga di verificare l’attendibilità delle parole del traduttore… Troppo maligno da parte mia pensarla così?
"Mi piace"Piace a 1 persona
Puoi segnalare tranquillamente le inesattezze direttamente ai Cercatori di Atlantide. Mi è capitato di farlo nel passato e hanno aggiornato l’articolo. Per quanto riguarda Savio, anch’io credo che si tratti di un errore (di Fatica o di chi ha trascritto l’intervento – c’è una piccola possibilità di un errore di comprensione o degli appunti scritti male). Ho provato a cercare pure io una possibile fonte per questa affermazione, ma non ho trovato niente. In riferimento al suggerimento nei commenti sopra – il libro di Cilli non lo riporta neanche.
"Mi piace"Piace a 1 persona
Perdonate la battuta, io faccio il medico, sono anestesista… e “convolvolo” mi farà sempre pensare al chirurgo che viene a chiamarmi per un addome acuto!
Dal sito dell’istituto superiore di sanità: “Il volvolo è un termine medico, che descrive la torsione dell’intestino su una struttura, chiamata mesentere, che collega l’intestino con l’addome, tenendolo saldamente ancorato al suo posto.”
Dottore, presto! Preparate la sala operatoria! C’è un paziente CONVOLVOLO in pronto soccorso!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Nessun problema, le battute sono tranquillamente ammesse! Un po’ di risate possono solo fare bene 🙂
"Mi piace""Mi piace"